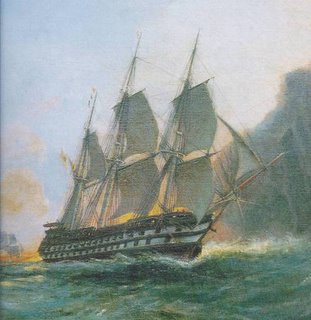 Migliaia di immigrati irregolari sono palesemente arrivati nel corso degli ultimi anni sulle spiagge della Sicilia, molto spesso proprio sotto l’occhio della televisione e con foto e servizi sulle prime pagine dei giornali. Eppure per la cosiddetta opinione pubblica (quella in cui l’Italia proietta se medesima e i suoi umori linguistici) tali immigrati rimangono “clandestini”: “la barca dei clandestini”, “lo sbarco dei clandestini”, “i clandestini sono stati trasferiti da Catania a Bari”.
Migliaia di immigrati irregolari sono palesemente arrivati nel corso degli ultimi anni sulle spiagge della Sicilia, molto spesso proprio sotto l’occhio della televisione e con foto e servizi sulle prime pagine dei giornali. Eppure per la cosiddetta opinione pubblica (quella in cui l’Italia proietta se medesima e i suoi umori linguistici) tali immigrati rimangono “clandestini”: “la barca dei clandestini”, “lo sbarco dei clandestini”, “i clandestini sono stati trasferiti da Catania a Bari”.
Al pari di altre apparenti incongruità, chiamare “clandestini” questi notorî nuovi ospiti (che aspirano talvolta a diventare membri effettivi della famiglia) è come lacerare il velo della decenza linguistica: quella garantita appunto dall’educazione e dalla conseguente ricerca di un’espressione appropriata (ciò che “clandestini” pare appunto non essere). Ma attraverso lo strappo baluginano particolari di verità, penosi e comici, dal lato del rapporto tra l’Italia pubblica e la sua lingua, problematici e meritevoli di riflessione, da quello del rapporto degli Italiani con se medesimi.
Che si definisca “clandestino” qualcuno i cui comportamenti non potrebbero essere più scoperti e manifesti sembrerebbe verifica dei tragici vaticini di profeti dell’apocalisse linguistica: George Orwell, Italo Calvino, George Steiner. Ma in Italia la tragedia si annida solo nei destini privati (e spesso sono appunto tragici quelli dei cosiddetti clandestini). Nella vita pubblica prevale il farsesco. Né a Orwell né a Calvino né a Steiner si chiederà così un commento a tali futilità più adeguato di quello che si deve a Nanni Moretti: l’urlo scomposto e più che vagamente volgare, per un retrogusto di accigliato e pedantesco moralismo (tipico di chi ha frequentato i buoni licei e le buone università), che in Palombella rossa il protagonista lancia contro la sua intervistatrice: “Ma come parli?!? Come parli?!? Le parole sono importanti! Come parli?!?”. A poche vicende linguistiche pubbliche nazionali, del resto, la combinazione di sortite pedestri e reazioni pedanti non si applica appropriatamente: il caso dei “clandestini” che sbarcano alla luce dei riflettori o del violento sole siciliano non è certo tra i più comici (restando tuttavia tra i più grotteschi).
In quel “clandestini” c’è però una seconda e forse più importante rivelazione (lo si diceva), per cogliere la quale il ricorso a qualcosa di più vero, com’è appunto la letteratura, sembra indispensabile. Alla penna di Joseph Conrad si deve se non il migliore certo il più noto racconto che, senza farne il protagonista (e come d’altra parte si potrebbe?), ruota intorno alla figura di un clandestino autentico: The Secret Sharer. Alla sua prima esperienza di comando, un giovane capitano nasconde in cabina e pericolosamente protegge un coetaneo fuggitivo, ricercato come presunto assassino. Egli scopre progressivamente nel segreto compagno un se stesso allo specchio e solo aiutandolo a salvarsi e a fuggire, consente a quel suo doppio e a se medesimo di accogliere la maturità come “his punishment", e a ciascuno di diventare “a free man, a proud swimmer striking out for a new destiny”.
In questi immigrati irregolari, in questi palesi “clandestini”, gli Italiani, emigranti per generazioni, si vedono allo specchio. Lo rivela quel nome, che pare destinato all’“altro” e dice invece del “sé” di chi lo dà. Sulle coste della Sicilia sta così semplicemente sbarcando, come può (e talvolta, tragicamente, già da cadavere), un doppio dell’Italia o un’Italia allo specchio. Saranno capaci gli Italiani di riconoscere se stessi e i propri doppi in quegli sbarchi e nei “clandestini”? Saranno capaci di aiutare se stessi e i “clandestini” a conquistare le rispettive e reciproche maturità, proiettandole da uomini liberi verso un nuovo destino?
Che si definisca “clandestino” qualcuno i cui comportamenti non potrebbero essere più scoperti e manifesti sembrerebbe verifica dei tragici vaticini di profeti dell’apocalisse linguistica: George Orwell, Italo Calvino, George Steiner. Ma in Italia la tragedia si annida solo nei destini privati (e spesso sono appunto tragici quelli dei cosiddetti clandestini). Nella vita pubblica prevale il farsesco. Né a Orwell né a Calvino né a Steiner si chiederà così un commento a tali futilità più adeguato di quello che si deve a Nanni Moretti: l’urlo scomposto e più che vagamente volgare, per un retrogusto di accigliato e pedantesco moralismo (tipico di chi ha frequentato i buoni licei e le buone università), che in Palombella rossa il protagonista lancia contro la sua intervistatrice: “Ma come parli?!? Come parli?!? Le parole sono importanti! Come parli?!?”. A poche vicende linguistiche pubbliche nazionali, del resto, la combinazione di sortite pedestri e reazioni pedanti non si applica appropriatamente: il caso dei “clandestini” che sbarcano alla luce dei riflettori o del violento sole siciliano non è certo tra i più comici (restando tuttavia tra i più grotteschi).
In quel “clandestini” c’è però una seconda e forse più importante rivelazione (lo si diceva), per cogliere la quale il ricorso a qualcosa di più vero, com’è appunto la letteratura, sembra indispensabile. Alla penna di Joseph Conrad si deve se non il migliore certo il più noto racconto che, senza farne il protagonista (e come d’altra parte si potrebbe?), ruota intorno alla figura di un clandestino autentico: The Secret Sharer. Alla sua prima esperienza di comando, un giovane capitano nasconde in cabina e pericolosamente protegge un coetaneo fuggitivo, ricercato come presunto assassino. Egli scopre progressivamente nel segreto compagno un se stesso allo specchio e solo aiutandolo a salvarsi e a fuggire, consente a quel suo doppio e a se medesimo di accogliere la maturità come “his punishment", e a ciascuno di diventare “a free man, a proud swimmer striking out for a new destiny”.
In questi immigrati irregolari, in questi palesi “clandestini”, gli Italiani, emigranti per generazioni, si vedono allo specchio. Lo rivela quel nome, che pare destinato all’“altro” e dice invece del “sé” di chi lo dà. Sulle coste della Sicilia sta così semplicemente sbarcando, come può (e talvolta, tragicamente, già da cadavere), un doppio dell’Italia o un’Italia allo specchio. Saranno capaci gli Italiani di riconoscere se stessi e i propri doppi in quegli sbarchi e nei “clandestini”? Saranno capaci di aiutare se stessi e i “clandestini” a conquistare le rispettive e reciproche maturità, proiettandole da uomini liberi verso un nuovo destino?
