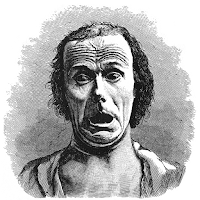Non millanta competenze chi coltiva con consapevolezza un interesse autentico per la lingua e ne fa oggetto di studio e di osservazione. Se ha atteso per molti decenni e con passione al compito, rivendica al massimo una lunga e strenua fedeltà. Non troppo differente da quella di una mosca che, attratta dalla luce scorta al di là di un vetro, non cessa di andare contro la superficie impenetrabile.
Dell'espressione, in una lingua non comune ("Mihi sic est usus; tibi ut opust facto face").
25 dicembre 2020
20 dicembre 2020
Bolle d'alea (30): Charles Nodier
"La faculté de prévoir l'avenir dans un certain ordre d'événements est fort indépendante, en effet, de révélations, de visions et de magie. Elle s'appartient à quiconque est doué d'une profonde sensibilité, d'un jugement droit, et d'une longue aptitude à l'observation. La raison du phénomène saute aux yeux. C'est que l'avenir est un passé qui recommence".
Charles Nodier, nel suo incompiuto M. Cazotte, detta queste parole rivelatrici. E ovvie, come sono sempre le rivelatrici, quando, sorgendo dall'esperienza di vita, la prendono a tema. Scoprono infatti ciò che è sotto gli occhi di ciascuno, ma diviene lampante solo nel momento gli si indirizza uno sguardo autentico. E, non c'è quasi bisogno di dirlo, ciò succede di rado.
Sono giorni in cui ritualmente si guarda al futuro e questo incostante diario giunge così al suo sedicesimo giro annuale. Forte della consapevolezza procuratagli dalle parole di Nodier, augura quindi a chi gli si accosta e lo segue con benevolente curiosità che la porzione di passato che si appresta appunto a ricominciare sia tra le fauste e liete e che la speranza, come sempre dovrebbe, si nutra di memoria.
16 dicembre 2020
Emulsioni culturali
Questo fermo-immagine e il testo che l'accompagna sono un mirabile esempio di una circostanza frequentissima nello stato presente della cultura nazionale (ma non solo della nazionale). Mostrano quanto può essere definito alla lettera un'emulsione culturale.
Un'emulsione è "una miscela", recita la relativa voce del Vocabolario on-line dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, "costituita dalla dispersione di goccioline di un liquido (fase dispersa o discontinua) in un altro (fase disperdente o continua) nel quale sono insolubili o quasi".
Nel caso specifico, la fase dispersa è costituita da Primo Levi e (non si può qui non concedere) dal saggio che ne fa oggetto e dall'autore di tale saggio: poniamo si tratti di olio, per traslato.
La fase disperdente è invece costituita da Striscia la notizia, la popolare trasmissione comico-satirica da cui è tratto il fermo-immagine, e più generalmente dalla società di comunicazione che la produce e la manda in onda e dal medium che la include e la rende possibile: per continuare con il traslato, l'acqua.
L'emulsione è un miscuglio ottenuto meccanicamente, una miscela eterogenea che si stabilizza momentaneamente, come si sa. A quanto pare, nel caso in questione, ciò si è verificato qualche sera fa per il pubblico televisivo. Con grande sbattimento, l'olio si è mescolato con l'acqua.
La benemerita casa editrice del saggio (essa fu, com'è appena il caso di ricordare, ispirata, voluta e animata un dì ormai lontano da Leonardo Sciascia, ma molto deve essere mutata) ha a questo punto pensato di tenere ulteriormente stabile l'emulsione, cioè la dispersione di Levi, Beccaria e del suo saggio in Striscia la notizia e nel resto che si è detto. Lo ha fatto con la comunicazione qui esposta, destinata a una rete sociale, con enfasi.
Con il fermo-immagine e con il testo di accompagnamento, il tweet riprende e rilancia in effetti il momento in cui l'emulsione si è prodotta, per il pubblico che l'avesse perso. In altre parole, per un'utenza diversa ma che si ritiene evidentemente comparabile con quella originale, esso continua a sbattere il miscuglio di modo che l'olio e l'acqua con cui è caducamente composto non si separino, come ineluttabilmente finiranno per fare.
Intrugli siffatti non sono nuovi, nella temperie. Si producono di continuo sotto il pretesto che sono fatti per il bene, per la maggior gloria delle patrie lettere e per un incalcolabile numero di altre nobilissime ragioni.
Apollonio non ne dubita, non ne mena scandalo né se ne dice nauseato. Evita comunque di avvicinarli troppo ai suoi organi dell'odorato e del gusto. Osserva e descrive, Apollonio, come al solito. E continua a seguire le orme di chi, proprio come Primo Levi, non smise mai di fare differenze (qui, in proposito, un piccolo scritto del suo alter ego).
9 dicembre 2020
Linguistica da strapazzo (46): "Può una spesa cambiare il mondo?"
I suoi due lettori lo sanno: gli riesce difficile fare l'una delle due cose senza associarla all'altra, in quest'ordine o nell'inverso. Il sorriso e il suo modesto contorno sono così tornati e diversamente da quel recente passato la pigrizia di Apollonio viene stavolta vinta dal desiderio di condividerli.
Ebbene, l'impianto discorsivo con cui la campagna si sviluppa è dialogicamente bipartito. In modo ovviamente artefatto, conta una domanda, esposta qui nel titolo e nella prima immagine, e una risposta affermativa. Eccola:
L'indeterminato una spesa è il fuoco tematico del messaggio: designa quanto esso indirizza i suoi destinatari a fare. L'attributo buona interviene a qualificarlo e sta lì il valore della replica. In funzione di tale attributo la modalità si trasforma da interrogativa in asseverativa, come dice inoltre il punto fermo conclusivo.
Si faccia attenzione. A potere cambiare il mondo non è una spesa qualsiasi, ma una spesa qualificabile come buona. L'attributo ha valore restrittivo e non descrittivo. Così direbbe chi padroneggia il gergo metalinguistico, senza avere perciò nessun particolare vantaggio nel cogliere intuitivamente la cruciale differenza, come appunto fa qualsiasi parlante.
Del ricorso nel messaggio alla lampante sottigliezza non c'è d'altra parte da stupirsi: avvicinandosi le feste, la campagna invita a spendere, ma non come e dove capita. La spesa, dice, va fatta "buona". E "buona" è proprio lì dove il committente del messaggio espone e vende la sua buona merce. Lo spiegano gli annunci ed è un'ovvietà, in questo tipo di testi, sulla quale non vale la pena di insistere.
Vale al contrario la pena di ricordare che l'aggettivo buono ha un larghissimo spettro di usi e che, nell'area coperta da tali usi, il confine tra materiale e morale praticamente non esiste. "Buona" può essere una pietanza, una circostanza, un'azione, una persona. E tutto ciò, spesso, secondo una catena metonimica: buono o buona è quanto o chi fa (del) bene. La spesa è qui considerata processualmente: è, in altre parole, un'azione e buono o buona è chi fa buone azioni. Questa plasticità o, se si vuole essere più crudi, questa ambiguità fa agio. Qui come quasi sempre. Si sarebbe tentati di dire: nel discorso pubblico, sempre.
Lungi dal collocarsi invariabilmente tra gli atti neutri, se non moralmente negativi del comportamento di una persona (si parlava un tempo in proposito di "consumismo"), la spesa può essere una buona azione e chi fa una buona spesa è (o può sentirsi) buono o buona. Il messaggio si appella alla sua bontà, meglio alla sua volontà d'essere o di apparire buono o buona. Al di là della bontà dell'azione singolare. La bontà della spesa ha infatti ben altra portata: "può cambiare il mondo". Se la spesa è il tema, è questo il rema (per servirsi ancora di una terminologia disciplinare) di domanda e correlata affermazione.
Ecco allora qualificata la porzione della popolazione che l'azienda vuole che si consideri la sua clientela d'elezione. È gente che si vede, si immagina, si prefigura non solo come buona e incline a fare buone azioni, secondo una consolidata tradizione religiosa nazionale, ma anche come potenziale soggetto di un cambiamento del mondo. Un cambiamento che, venendo da gente buona, è naturale che sia per il meglio e un mondo che, con metonimia visuale, sta per intero nel suo carrello.
Ed ecco detto correlativamente quale sia il bacino ideologico o, forse meglio, al giorno d'oggi mistico-sentimentale nel quale si muovono questi clienti ideali. Nei punti-vendita di quella azienda, ciò che acquistano, mentre gettano nel loro carrello biscotti per la colazione, carta igienica, salmone norvegese e croccantini per il cane o per il gatto, è (ohibò!) il potere di cambiare il mondo per il meglio: il più grande sogno della Modernità. Un sogno che più di una volta è parso e ancora oggi pare prendere, pur sotto forme diverse, l'aspetto di un incubo. Ma tant'è.
Ora, è superfluo che Apollonio dica a chi sta leggendo questo frustolo di quale tradizione moderna sia estrema e ormai unica rilevante erede, nell'arena pubblica nazionale, la grande azienda italiana della distribuzione organizzata secondo il modello cooperativo che parla attraverso i messaggi qui in questione. Una tradizione univocamente e integralmente volta a cambiare il mondo per il meglio.
Altrettanto inutile è forse ricordare come, proprio da parte di quella tradizione, per il cambiamento del mondo si siano sul principio immaginate come necessarie e ineluttabili azioni collettive di norma politicamente orientate e, dandosi il caso, anche violente: le cosiddette rivoluzioni. O ricordare ancora come, tramontata quell'epoca che si può oggi dire eroica, senza che si abbandonasse la prospettiva politico-sociale per cambiare il mondo, si fosse successivamente venuti all'idea di riforme da realizzare pacificamente, conquistando con procedure dette democratiche un largo consenso, grazie alla delega della rappresentanza espressa con il voto.
Non è da ieri però che la Modernità si è putrefatta e si sono fatte correlativamente liquide le sue tradizioni, non escluse le politiche. Nella putrefazione moderna lo spazio delle rivoluzioni è ormai occupato per intero dalle tecnologie. Nei loro diversi campi, ne fanno perlomeno una per semestre.
Quanto poi al voto, come alla rappresentanza politica e alla relativa delega a riformare, non ci vuole molto a osservare come, nell'universale liquidità o, forse, nel liquame, siano tutte cose ridotte al ruolo di giochi vacui. A costi di produzione contenuti, vista la scadente qualità dei protagonisti, e quindi diversamente da quanto accade con i giochi dichiaratamente sportivi, se ne serve la comunicazione pubblica, cioè un attore economico-sociale ormai imponente, nelle sue forme tradizionali e non. Con le cangianti figurine di tali giochi, con le loro baruffe, vere o simulate che siano, con gli echi chiassosi che esse provocano in una piazza virtuale frequentata da ogni sorta di scalmanati e scalmanate virtuali si alimenta infatti il suo flusso diluviale.
Insomma, la grande azienda italiana della distribuzione organizzata secondo il modello cooperativo, estrema e ormai unica rilevante erede di una grande tradizione moderna volta al cambiamento, offre a buoni e buone un tempo e un'occasione di intervento: quelli della spesa. E offre anche uno spazio: quello dei propri punti-vendita. Beninteso, finché costoro avranno qualche danaro in tasca, condizione che potrebbe peraltro cambiare, e rapidamente.
Un buon acquisto o un acquisto buono al posto del voto, al posto della rivoluzione. E visti gli scarsi e deludenti risultati dei precedenti, c'è persino il rischio che il modo di cambiare il mondo che si vorrebbe nuovo si riveli (ohibò!) quello "buono". Finalmente.
Una prospettiva bottegaia, dirà qualche incontentabile. Innegabilmente, ben a proposito. Ma, al punto in cui si è, come escludere che, come si fa per ogni altra cosa, per cambiare il mondo, per averne uno migliore, senza faticare o mettersi in prove che oggi si direbbero estreme, basti comprarlo?
27 novembre 2020
Linguistica candida (55): In barba a Occam
A chi l'osserva con devota attenzione, la lingua dice di se stessa come funziona. Invece, per discettare di suoi caratteri talvolta peregrini, pretendendo addirittura di spiegarli, molta linguistica, con perversa, onirica e crescente ostinazione, fantastica di enti di ogni specie, detti un tempo soprattutto semantici e grammaticali, oggi cognitivi. E sono tanti ormai tali enti che, per tagliarli via, al celebre rasoio si guasterebbe il filo.
23 novembre 2020
Cronache dal demo di Colono (66): I monopattini ultra-moderni
Migliaia e migliaia di monopattini hanno cominciato a scorrazzare da qualche tempo nelle città. A bordo non ci sono bambini o bambine e le persone adulte che se ne servono non hanno nemmeno l'aria di chi cerca giustificazioni per farlo. Anzi.
È l'andazzo e a sostegno di un andazzo una propaganda ideologica non fa mai difetto. Le ragioni di tale propaganda sono a dire il vero le più bislacche, ma non c'è da stupirsene. Tutto ciò che è reale, è stato autorevolmente detto, è razionale (quasi sempre a cose fatte: ma è un dettaglio). Forse, va tuttavia aggiunto che, se si rovista con un po' di senso critico nel reale, vi si scovano un sacco di cose che, benché razionali, sono irresistibilmente comiche. Sarà il caso dei monopattini che qui si diranno ultra-moderni e del loro uso? Oggetti razionalmente comici o comicamente razionali, disposti a un uso che, razionalissimo, fa in effetti morire dal ridere.
Perché ultra-moderni? Perché i monopattini di cui si sta dicendo non procedono a forza di gambe, come ancora quelli a questo punto da considerare pre-ultra-moderni e bambineschi. A muoverli è un motore elettrico alimentato da una batteria. Poco sa Apollonio della produzione di tale batteria. Ancora meno di come, esauritasi dopo molte ricariche, la si smaltisce. Sospetta che ambedue le procedure siano perlomeno delicate dal punto di vista ambientale.
Ma non si vuole stare qui a sottilizzare sopra questioni che poco o nulla si padroneggiano. Il succo di questo frustolo non ne dipende e ciò che con esso si vuole dire è lampante. Diversamente da quanto accadeva con i monopattini pre-ultra-moderni e bambineschi, con i monopattini ultra-moderni ci si scarrozza chiome al vento senza sudare. In questo sta il loro valore: come bambini, sì, ma, proprio in quanto non più bambini, niente sforzi, per carità.
La combinazione dice cosa sono i monopattini ultra-moderni, da elementi dell'espressione sistematica della temperie, e spiega socio-antropologicamente il correlato andazzo.
I monopattini ultra-moderni (o, che è lo stesso, della modernità putrefatta) sono un sintomo ulteriore e loquacissimo dell'infantilismo senile di una società e forse di una civiltà. Sono insomma, ancora una volta, una disarmante manifestazione di rimbambimento.
19 novembre 2020
17 novembre 2020
Echi di Eco
"La semiotica ha a che fare con qualsiasi cosa possa essere ASSUNTA come segno. È segno ogni cosa che possa essere assunto come un sostituto significante di qualcosa d'altro. Questo qualcosa d'altro non deve necessariamente esistere, né deve sussistere di fatto nel momento in cui il segno sta in luogo di esso. In tal senso, la semiotica, in principio, è la disciplina che studia tutto ciò che può essere usato per mentire".
Sono celebri e sovente citate parole di Umberto Eco, tratte dalla pag. 17 del suo Trattato di semiotica generale (Bompiani, Milano 1975; maiuscolo e corsivo, si precisa, sono nell'originale).
Non si ha qui titolo per dire se esse, a loro volta, mentano o dicano il vero, anche perché ragionevole è il sospetto che, proprio al loro riguardo, l'alternativa non si ponga e che, anche se paiono teoria, siano narrazione. Bella, efficace, seducente narrazione, va detto.
Utile è invece osservare il modo con cui, grazie a esse, Eco propone non di delimitare né di determinare, ma di qualificare lo sterminato, si direbbe appunto ecumenico campo di intervento di cui si proclama proprio in quegli anni letteralmente guardiano ("gatekeeper", disse nel 1974, in chiusura del primo congresso della Associazione internazionale di studi semiotici). Lo fa tirando in ballo la menzogna, con un effetto superficiale di straniante anticonformismo. Per correlazione ineluttabile, a essere però chiamata in causa è così la verità. E la brillante sortita appare allora parlante manifestazione di una forma mentis e del conio che l'ha prodotta: da quel conio è sortito il pensiero di Eco.
Uno sguardo che lentamente si allontana ne individua i tratti portanti e comincia così a intendere chi sia stato e cosa abbia rappresentato Umberto Eco nella secolare tradizione della cultura (nazionale).
L'epilinguistica ferroviaria d'un dì, oggi
Origine del linguaggio, etimologie sempre rivelatrici (e talvolta peregrine), dubbi ed errori grammaticali. Nei compartimenti dei treni, quando ancora i treni avevano compartimenti, era impossibile non si producesse un effimero salotto e non si intrecciassero conversazioni, soprattutto durante i lunghi spostamenti. Se un viaggiatore, con altri frammenti di vita, lasciava trapelare un interesse per la lingua, si poteva stare certi che, nella chiacchierata, uno di quei tre temi si sarebbe imposto. Spesso più d'uno.
Sono proprio i temi sotto i quali, in un modo o nell'altro e a diversi livelli di (pretesa) specializzazione, ricade oggi una buona fetta di ciò che circola pubblicamente come linguistica: dubbi ed errori grammaticali, etimologie sempre rivelatrici (e talvolta peregrine), origine del linguaggio.
9 novembre 2020
Onomastica letteraria (1): Palomarcovaldo
Con candida attenzione, vale la pena di osservare che l'ultima sillaba di Palomar è la prima di Marcovaldo. Senza sognare subito che chissà cosa voglia dire. Senza cominciare a specularci sopra. Ma con il consapevole dubbio che non si tratti di un accidente e che ciò che inoppugnabilmente si osserva manifesti, come variata iterazione in un sistema complesso, tanto una relazione, quanto una differenza. Con la parola di Italo Calvino e con le sfide che essa lancia a chi la legge, così forse andrebbe sempre fatto.
28 ottobre 2020
A frusto a frusto (126)
C'è senza dubbio un morbo dal quale si diviene rigorosamente immuni aggregandosi a un gregge: la ragionevolezza.
2 ottobre 2020
16 settembre 2020
Divulgazione
Il guaio della cosiddetta divulgazione è che, poi, c'è sempre qualcuno che si mette a divulgare ulteriormente quel poco che vi ha per avventura afferrato. E ancora, chi non si perita di divulgare il già doppiamente divulgato e così via, senza limiti.
Non c'è pertanto delicato pensiero di cui chi divulga s'impadronisca che, lungo una siffatta traiettoria verso il basso, precipitando a cascata, divulgazione dopo divulgazione, non piombi inarrestabilmente nella brulicante palude delle infinite volgarità.
15 settembre 2020
Cronache dal demo di Colono (65): "Domani"
È nato oggi, apprende Apollonio, un nuovo quotidiano, la cui testata recita Domani: c'è da credere intenda così corrispondere nel miglior modo allo spirito del tempo.
Lampante che la fantasia dell'onomaturgo sia stata in proposito riflessivamente ottativa. Lo stato in cui versa oggi la stampa in Italia induce infatti a chiedersi quale domani e quale dopodomani avrà Domani.
Ma dietro la scelta di un nome a ben vedere tanto impegnativo non sarà certo mancata la relativa e preliminare indagine di mercato.
Tutti parlanti indizi insomma che, stanca ormai del presente stato di se stessa e della sua rappresentazione giornalistica, la nazione o perlomeno quella parte della nazione che la pubblicazione immagina come proprio pubblico ideale vuole soprattutto leggere oroscopi.
10 settembre 2020
23 agosto 2020
I cabasisi di Salvo Montalbano
Come ogni officina, anche quella dell'alter ego di Apollonio ha un banco di prova. Riccardino, l'estremo prodotto della penna di Andrea Camilleri (estremo, al momento), sta lì, con altra roba, in attesa di un'occasione che forse non verrà mai. Apollonio lo sfila dalla pila e comincia a scorrerlo. In fondo a pagina 12, "I cabasisi a Montalbano gli principiarono a firriari tanto vorticosamenti che si scantò di decollari da un momento all'autro". Legge e non riesce ad andare oltre. Gli si mette di traverso non un pensiero definito, ma una sorta di immagine fantasmatica. Nella figura, riconosce un Luigi Pirandello ideale nei tratti e dall'attitudine severa.
I due lettori di questo diario lo sanno: chi lo detta è un tipo strambo e strambe e cervellotiche sono spesso le sue associazioni di idee. Stavolta, però, l'appena riferita epifania interiore non si può dire sia effetto di tale bizzarria spirituale. L'uscita dell'ultimo episodio della serie del commissario Montalbano è stata annunciata a più riprese durante l'anno che è trascorso dal giorno della morte del suo creatore e, negli ultimi mesi, cioè alla vigilia di un'estate di ombrelloni domestici e di letture da spiaggia caserecce, è stata accompagnata da un'intensa campagna promozionale. Di tale campagna, Luigi Pirandello è stato proposto come testimonial virtuale e il suo nome vi è stato evocato senza risparmio, non solo per le arcinote ragioni di congruenza geografica. "Autore", "personaggio" e altri connessi luoghi comuni ne hanno in effetti annobilito oltremodo gli accenti.
Che dunque alla lettura di "I cabasisi a Montalbano gli principiarono a firriari tanto vorticosamenti che si scantò di decollari da un momento all'autro" lo spirito di un Apollonio qualsivoglia possa popolarsi fantasmaticamente dell'ombra di un severo Luigi Pirandello e che tale ombra gli imponga di non procedere oltre "ci può stare" (come oggi pare si debba dire per riferirsi a ciò che è prevedibile). Ma non è tutto.
Che dunque alla lettura di "I cabasisi a Montalbano gli principiarono a firriari tanto vorticosamenti che si scantò di decollari da un momento all'autro" lo spirito di un Apollonio qualsivoglia possa popolarsi fantasmaticamente dell'ombra di un severo Luigi Pirandello e che tale ombra gli imponga di non procedere oltre "ci può stare" (come oggi pare si debba dire per riferirsi a ciò che è prevedibile). Ma non è tutto.
Sbigottito, Apollonio ha appena finito di rileggere "I cabasisi a Montalbano gli principiarono a firriari tanto vorticosamenti che si scantò di decollari da un momento all'autro" che, sempre nella sua visione interiore, un'altra figura emerge lentamente alle spalle di Pirandello: lo spettro di Leonardo Sciascia. Anche lui gli intima l'alt.
Di nuovo, albergare fantasie incongrue è certo difetto, se non colpa di Apollonio, ma chi non ammetterebbe in tal caso l'esistenza di attenuanti? Tra le mani ha un libro dalla copertina blu di Prussia, copertina che fa da inconfondibile marchio di una collana, "La memoria" e, con tale collana, di una casa editrice, per una metonimia giustificatissima dai dati di vendita. E non fu Leonardo Sciascia ad animare nascita, infanzia e prima giovinezza di quella casa editrice e a volervi specificamente quella collana? Non fu Sciascia a battezzare la collana con un nome tanto impegnativo? Non c'è o non potrebbe esserci ancora oggi l'ombra di Sciascia nascosta sotto il risvolto di copertina di ogni libro che la fa crescere di numero?
E poi Racalmuto e, oggi, Porto Empedocle, ambedue a due passi da Agrigento, anzi, dalla Girgenti, appunto, di Pirandello. Calliope getta un passo e ne tocca una delle tre, sciogliendovi cera della sua tavoletta, a beneficio dei locali aedi, pronti a rimodellarla. Saranno contigue di conseguenza Vigata e Regalpetra, fatte della medesima cera. Apollonio le ha sempre viste non tanto lontanissime, quanto incommensurabili, ma sarà lui lettore tardo e privo di penetrazione, incapace di intendere che per un Racine, per uno Stendhal, c'è un Rabelais.
Fatto sta che lo spettro di Sciascia, risentito, come Sciascia fu peraltro in vita, s'unisce a quello severo di Pirandello e i due non si muovono. Trattengono ancora Apollonio sopra quella frase. Gli ingiungono di compitarla: "I ca-ba-si-si a Mon-tal-ba-no gli prin-ci-pia-ro-no a fir-ria-ri tan-to vor-ti-co-sa-men-ti che si scan-tò di de-col-la-ri da un mo-men-to al-l'au-tro".
Da lì, da un esercizio tanto improbabile e gratuito, d'improvviso, non un'illuminazione, ma l'oscura finestra di un dubbio.
Nella fine figura del turbinoso girare dei coglioni di Salvo Montalbano, nel correlato e aereo tropo del suo conseguente timore di sollevarsi finalmente in volo ci sarà, bene o male, bello o no, il quid artistico e letterario dell'opera di un Andrea Camilleri mai troppo rimpianto? È questo che, ostacolandogli pervicacemente il cammino con il loro corruccio, le due vane larve, i due sdegnosi lemuri vogliono che Apollonio intenda?
Da lì, da un esercizio tanto improbabile e gratuito, d'improvviso, non un'illuminazione, ma l'oscura finestra di un dubbio.
Nella fine figura del turbinoso girare dei coglioni di Salvo Montalbano, nel correlato e aereo tropo del suo conseguente timore di sollevarsi finalmente in volo ci sarà, bene o male, bello o no, il quid artistico e letterario dell'opera di un Andrea Camilleri mai troppo rimpianto? È questo che, ostacolandogli pervicacemente il cammino con il loro corruccio, le due vane larve, i due sdegnosi lemuri vogliono che Apollonio intenda?
17 agosto 2020
Del dato
L'immagine che illustra questo frustolo circola da un po' nelle reti sociali: è un meme. Apollonio non sa dire chi l'abbia concepita né chi l'abbia realizzata. A ondate, la vede diffusa o, come usa dire adesso, condivisa da gente che, non solo in quelle sedi, si presenta al mondo come dedita alle scienze, meglio, alla Scienza.
Diffusa e condivisa con una buona intenzione: criticare le attitudini qualificate, secondo le varie terminologie, come cospirazioniste, complottiste, dietrologiche che nel discorso pubblico dell'Evo moderno non sono mai mancate (ce ne sono state di tragicamente celebri) e che oggi spesseggiano, amplificate appunto dalle reti sociali e dai fenomeni culturali connessi.
C'è da chiedersi tuttavia se, pur per uno scopo che si vuole nobile, sia il caso di propalare e di ribadire con tale immagine la sesquipedale sciocchezza che ἐν ἀρχῇ ci siano i dati: veri e propri feticci dell'attuale temperie culturale.
Come sa chiunque pratichi con qualche consapevolezza una scienza (e per tale ragione è difficile si presenti come chierico di alcunché, tanto meno della Scienza), non c'è infatti dato che non sia un costrutto complesso, che non sia, in altre parole, il punto di arrivo di un meditato percorso di conoscenza e, se si vuole, di complessiva saggezza.
Di "dato", insomma, non c'è nulla per gli esseri umani e tutto, proprio tutto deve essere faticosamente, oltre che precariamente, preso e compreso; tutto va sempre discutibilmente conquistato.
Credere che, fuori del lavorio umano che lo produce, della pena che costa, delle complesse implicazioni teoretiche ed etiche, dei contenuti culturali che porta con sé, miracolosamente il dato ci sia non è in sostanza diverso dal prestare fede a una qualsivoglia scalcagnata teoria cospirazionista. Dietro la pretesa di serietà, potrebbe essere persino più pericoloso.
Una persona ragionevole (non si vuol dire semplicemente una persona di scienza) dovrebbe in ogni caso guardarsi bene dal diffondere, anche solo per allusione, tuttavia in modo in ogni caso volgare, una balla di tali dimensioni. Ed è un peccato che alle fanfaluche delle dietrologie si finisca così per contrapporre, come modello, una sorta di credo.
Diffusa e condivisa con una buona intenzione: criticare le attitudini qualificate, secondo le varie terminologie, come cospirazioniste, complottiste, dietrologiche che nel discorso pubblico dell'Evo moderno non sono mai mancate (ce ne sono state di tragicamente celebri) e che oggi spesseggiano, amplificate appunto dalle reti sociali e dai fenomeni culturali connessi.
C'è da chiedersi tuttavia se, pur per uno scopo che si vuole nobile, sia il caso di propalare e di ribadire con tale immagine la sesquipedale sciocchezza che ἐν ἀρχῇ ci siano i dati: veri e propri feticci dell'attuale temperie culturale.
Come sa chiunque pratichi con qualche consapevolezza una scienza (e per tale ragione è difficile si presenti come chierico di alcunché, tanto meno della Scienza), non c'è infatti dato che non sia un costrutto complesso, che non sia, in altre parole, il punto di arrivo di un meditato percorso di conoscenza e, se si vuole, di complessiva saggezza.
Di "dato", insomma, non c'è nulla per gli esseri umani e tutto, proprio tutto deve essere faticosamente, oltre che precariamente, preso e compreso; tutto va sempre discutibilmente conquistato.
Credere che, fuori del lavorio umano che lo produce, della pena che costa, delle complesse implicazioni teoretiche ed etiche, dei contenuti culturali che porta con sé, miracolosamente il dato ci sia non è in sostanza diverso dal prestare fede a una qualsivoglia scalcagnata teoria cospirazionista. Dietro la pretesa di serietà, potrebbe essere persino più pericoloso.
Una persona ragionevole (non si vuol dire semplicemente una persona di scienza) dovrebbe in ogni caso guardarsi bene dal diffondere, anche solo per allusione, tuttavia in modo in ogni caso volgare, una balla di tali dimensioni. Ed è un peccato che alle fanfaluche delle dietrologie si finisca così per contrapporre, come modello, una sorta di credo.
14 agosto 2020
Bolle d'alea (29): Flaubert
"Un temps viendra où l'on ne cherchera plus le bonheur - ce qui ne sera pas un progrès, mais l'humanité sera plus tranquille" scrive Gustave Flaubert domenica 18 dicembre 1859 a Mademoiselle Leroyer de Chantepie. Evidentemente, quel tempo non è ancora venuto e in quel futuro risiede una delle illusioni nutrite anche da chi, come lo scrittore francese, trovò nella precisa espressione della disillusione la sua eroica grandezza.
Dubitando che in realtà non si tratti proprio di progresso, più tranquillità e meno ricerca della felicità paiono tuttavia ad Apollonio due disposizioni d'animo augurabili oggi e il modesto indice temporale di tale augurio ha qui valore proprio e, come sineddoche, figurato.
10 agosto 2020
Indirizzi di metodo, per giovani che non ne necessitano (26): Assoluto, relativo, pertinente
Lo sguardo critico, lo sguardo di chi discerne è sempre nuovo. La novità lo fa giudicare insolente da coloro che credono nell'assoluto e ingenuo da coloro per cui tutto è relativo.
Lo sguardo critico non è invece né insolente né ingenuo, anche perché è l'unico cui è chiara l'elegante esigenza di un metodo.
Con metodo, esso va a caccia di ciò che è pertinente, al di là di ciò che molti credono assoluto e di ciò che altrettanti si contentano di dire relativo. Individuando ciò che è pertinente, prova in altre parole a determinare cosa c'è di diverso dove nulla pare esserlo e cosa di eguale dove nulla pare esserlo.
Alla ricerca della pertinenza pone ostacoli non solo teoretici, ma anche etici tanto chi crede all'assoluto, quanto chi si arrende al relativo. E tra i primi risultati procurati dallo sguardo critico metodologicamente orientato c'è la scoperta della pertinente relazione che, dietro differenze fenomeniche, rende reciprocamente solidali chierici dell'assoluto e araldi del relativo.
4 agosto 2020
Per chi si scrive? Una risposta, poco nota, di Leonardo Sciascia (e una, ben nota, di Italo Calvino)
"Lo scaffale ipotetico" è un piccolo saggio del 1967 di Italo Calvino. A sollecitarne la composizione era stata un'inchiesta "aperta da Gian Carlo Ferretti sul tema: Per chi si scrive un romanzo? Per chi si scrive una poesia?" e ospitata dal settimanale Rinascita, il periodico politico-culturale fondato nel 1944 da Palmiro Togliatti (difficile immaginare, per una pubblicazione, un nome più aderente al programma di conciliazione delle diverse anime della cultura nazionale perseguito dal suo fondatore; Rinascita finì nella pressa della storia quarantacinque anni dopo la sua fondazione e vi fu definitivamente stritolato nel 1991).
Dal tema dell'inchiesta che gli aveva sollecitato un intervento, Calvino prese d'altra parte a prestito un nuovo titolo per il suo scritto, quando nel 1980 lo ripubblicò. E così il saggio comparve come "Per chi si scrive? (Lo scaffale ipotetico)" nella raccolta Una pietra sopra. Discorsi di letteratura e società. In tale sede Apollonio (o il suo alter ego) lo lesse or sono appunto quattro decenni e da quel momento si fece cosciente e convinto di un'idea che vi è prospettata: "se si presuppone un lettore meno colto dello scrittore e si assume verso di lui un'attitudine pedagogica, divulgativa, rassicuratrice, non si fa che confermare il dislivello [culturale tra colti e incolti]; ogni tentativo d'edulcorare la situazione con palliativi (una letteratura «popolare») è un passo indietro, non un passo avanti. La letteratura non è la scuola; la letteratura deve presupporre un pubblico più colto, più colto di quanto non sia lo scrittore [il corsivo è di Calvino]; che questo pubblico esista o no non importa. Lo scrittore parla a un lettore che ne sa più di lui, si finge un se stesso che ne sa di più di quel che lui sa, per parlare a qualcuno che ne sa di più ancora".
Non mancherà occasione ad Apollonio (o forse, e meglio, al suo alter ego) di tornare su tale idea, dicendo come essa sia pertinente per comprendere e collocare opportunamente non solo recenti fenomeni letterari come il caso Camilleri, ma anche, al di là della letteratura e dei suoi aspetti squisitamente bellettristici, a intendere la natura ideologicamente regressiva, se non apertamente reazionaria di una grande quantità dell'attuale diffusione a stampa o in rete di testi d'impianto, si dice, saggistico e con pretese di divulgazione.
Sugli stessi temi, suona anche oggi pertinentissima la risposta che Leonardo Sciascia diede per altri versi alla medesima inchiesta. Essa comparve proprio nel fascicolo di Rinascita (anno XXIV, n. 46, novembre 1967) in cui Calvino aveva proposta la sua. Molto più breve e molto meno ideologicamente sofisticato di quello di Calvino, lo scritto di Sciascia è anche molto meno noto e ha un titolo, "Tra impegno e disimpegno", che oggi sa di tappo e forse non gli rende giustizia. Sciascia non lo ripropose nelle sue raccolte saggistiche ed è assente dalle successive edizioni delle sue opere. Per quanto Apollonio ne sappia, non è quindi mai stato ripubblicato. Gli pare quindi di rendere un servizio ai suoi due lettori, riproponendolo qui nella sua interezza.
Sciascia scrisse così: "Ho cominciato a scrivere in tempi di impegno; continuo a scrivere in tempi di disimpegno. Non ho tenuto conto dell'impegno (com'era inteso); e non tengo conto del disimpegno (com'è inteso). O dell'impegno del disimpegno, del disimpegno dell'impegno del disimpegno, e così via.
Guardando alla società italiana nel suo insieme (e dico società in senso del tutto approssimativo) e a quello che in questa società accade da venti anni, da cento, da quattrocento, mi sentivo inutile ai tempi dell'impegno e mi sento inutile in questi tempi di disimpegno. Non ho mai scritto, dunque, pensando a una società pronta ad accogliere i miei libri o a respingerli; e tanto meno pensando a una classe pronta ad accoglierli e a un'altra pronta a respingerli. D'altra parte, non ho mai scritto per me stesso: quello che scrivo è importante per me soltanto per il fatto che lo comunico agli altri; cioè per il fatto che quello che vengo a conoscere o a riconoscere scrivendo appunto lo conosco o lo riconosco nel circuito della comunicazione.
Ma chi sono questi altri coi quali comunico (o mi illudo di comunicare, poiché un margine pirandelliano c'è sempre in tutto quello che faccio, in tutto quello cui credo)?
È difficile rispondere indicando categorie, tipi, ambienti. Posso solo dire: sono persone che conosco.
Non il lettore-consumatore, dunque, ma il lettore-interlocutore. Un lettore individualizzato al massimo, direi, e col quale sono riuscito a stabilire un rapporto, molto somigliante all'amicizia, sulla base del senso comune (non dico buon senso per le implicazioni qualunquistiche che ha da noi l'espressione) [i corsivi sono di Sciascia].
E avendo raggiunto un numero piuttosto ingente di lettori-amici (cosa piuttosto difficile in un paese come il nostro), potrei anche essere soddisfatto e sicuro. E invece non sono né soddisfatto né sicuro. Questa vasta cerchia di lettori altro non è che l'allargamento della rosa manzoniana dei venticinque. E perciò come don Abbondio resto a dire: ci vuol altro, ci vuol altro, ci vuol altro; appunto perché quel che ci vuole quasi non si vede più e a tentare di mutare la situazione, il rapporto, si scivola nel peggio.
A perdere il lettore della qualità dei venticinque del Manzoni, altro non si trova che il lettore consumatore, cioè il lettore invisibile. Qui, dico, oggi. E ne vale la pena?"
Ci si intenda, c'è sempre stato da qualche secolo chi ha pensato di sì, volgarmente convinto del fatto che lettrici e lettori ideali siano ebeti e insipienti. In altre parole, c'è sempre stato chi, spacciandosi per popolare con lampante falsa coscienza, ha pensato valesse la pena, scrivendo, di ordire i facili imbrogli dell'imbonitore.
Qualcosa è però cambiato, dai tempi di Calvino e di Sciascia, tutto sommato recenti. Oggi pare non ci sia quasi più nessuno che, chiedendosi "per chi scrivo?", abbia pensieri simili ai loro. Che non ci sia quasi nessuno disposto a sottoscrivere in piena coscienza la perentoria e moralmente temeraria dichiarazione che Leonardo Sciascia, spavaldo davanti alla morte, affidò a Georges Bernanos, nell'epigrafe del suo estremo (e tragico) A futura memoria (se la memoria avrà un futuro): "Preferisco perdere dei lettori, piuttosto che ingannarli".
2 agosto 2020
Linguistica candida (53): "it's none of your business"
Nel rumoroso cortile della comunicazione pubblica nazionale è esplosa in questi giorni una furibonda baruffa. Pretesto, più che ragione, ne sono stati i modi con cui nello scritto italiano, in alcune circostanze, ci si potrebbe (c'è chi opina, ci si dovrebbe) esimere da quell'espressione di un genere grammaticale che la lingua di Dante impone a chi se ne serve.
Ad Apollonio è così tornato in mente un passo di Roman Jakobson. Lo si legge nel suo scritto più sapiriano, consacrato del resto a Franz Boas. Dalla scuola di Boas Edward Sapir era appunto uscito. Il passo contiene una delle più affilate e celebri sortite di Jakobson: "Thus the true difference between languages is not in what may or may not be expressed but in what must or must not be conveyed by the speakers". E sapiriana ne è la spiritosa illustrazione (oltre che frutto diretto e palese dell'Erlebnis del linguista russo trapiantato negli Stati Uniti): "If a Russian says: Ja napisal prijateliu 'I wrote a friend', the distinction between the definiteness and indefiniteness of reference ('the' vs. 'a') finds no expression, whereas the completion of the letter is expressed by the verbal aspect, and the sex of the friend by the masculine gender. Since in Russian these concepts are grammatical, they cannot be omitted in communication, whereas after the English utterance «I wrote a friend», interrogations whether the letter has been finished and whether it was addressed to a boy-friend or to a girl-friend, can be followed by the abrupt reply - «it's none of your business»".
15 luglio 2020
Le occasioni di ridere... (4)
non vanno mai sprecate. Eccone una:
Ci si intenda: sono cose che capitano.
A quanto pare, la topica sta tuttavia lì da tre anni (chi vuole può leggere qui il resto). E nessuno ha messo sull'avviso l'autrice e il portale france culture (sic!). Portale (i due lettori di Apollonio certamente lo sanno) che spalleggia in rete l'un dì mitica stazione radiofonica culturale dell'emittente pubblica francese. Quando si dice il declino...
Del resto, a stare a non fare niente, cosa si vuole che succeda? Ineluttabile che prima o poi si vada se faire voir chez les Grecs.
28 giugno 2020
Sommessi commenti sul Moderno (27): Chiesa ovunque
Ci sono state epoche, che sono state dette bigotte, e luoghi, che sono stati considerati asfittici, in cui per ascoltare chi diceva come ci si dovesse comportare bisognava andare in chiesa.
Adesso, in qualsiasi luogo, basta esporsi, come destinatario o come destinataria, a qualsivoglia forma di comunicazione: privata e pubblica, scritta e orale, digitale e analogica, artistica e no.
Dappertutto, c'è la certezza di incappare in chi detta precetti e lancia anatemi, prescrive e stigmatizza, s'indigna e grida allo scandalo, giudica e manda.
La predica morale, con le connesse deprecazioni, è il genere che caratterizza la temperie ed è tale sua corriva volgarità a dire che le sue innumerevoli evenienze non possono avere il solo tratto che le riscatterebbe, come del resto ha fatto in altri momenti: una rigorosa qualità letteraria.
Si può anche predicare bene, infatti, ma per farlo niente è più superfluo di nutrire buoni sentimenti e migliori intenzioni.
Insomma, ennesima sineddoche del suo ridicolo fallimento morale, il Moderno ha fatto maldestramente deserto delle belle chiese per liquefarsi, graveolente, in un tempo in cui chiesa, e chiesa qualunque è ovunque.
6 giugno 2020
Sommessi commenti sul Moderno (26): La paura in maschera
In una temperie che non è ancora completamente trascorsa e che probabilmente non solo non trascorrerà in fretta, ma lascerà sedimenti morali e materiali anche di lunga durata, al di là della questione dell'appropriatezza delle misure adottate, qui fuori della pertinenza, fa sorridere e dovrebbe fare meditare che il discorso pubblico abbia dipinto e incoraggiato come una proba prova di civismo ciò che si è invece configurato e sviluppato come una dannata strizza individuale o, al massimo, familista. Insomma, la paura personale ha circolato e circola discorsivamente e ideologicamente mascherata da civica virtù.
Se ne può sorridere e ci si può riflettere sopra, si diceva, senza proclamare in proposito indignazioni. A modernità ormai putrefatta, sarebbe infatti stupido attendersi che le cose vengano chiamate con i loro nomi dal discorso pubblico e dagli innumerevoli rivoli dei discorsi semi-privati e privati che ne discendono e ne diffondono capillarmente modi e contenuti. E stupido e malandrino (fare sembiante di) avere l'ineludibile pretesa di sentire dire pane al pane e vino al vino.
Come se non si sapesse da più di due secoli che, con quel discorso chiassoso e con i suoi vocianti succedanei, a ogni persona che tiene alla sua libertà e alla sua integrità tocca interagire, per via di mera testimonianza, con una pacatezza critica, leggera e rassegnata. Soprattutto senza alzare i toni e senza mirare all'ascolto di chicchessia, dal momento che, alzandoli, si fa il suo gioco ed è appunto nell'ascolto di chicchessia che esso ha il suo ubi consistam.
Come se non si sapesse da più di due secoli che, con quel discorso chiassoso e con i suoi vocianti succedanei, a ogni persona che tiene alla sua libertà e alla sua integrità tocca interagire, per via di mera testimonianza, con una pacatezza critica, leggera e rassegnata. Soprattutto senza alzare i toni e senza mirare all'ascolto di chicchessia, dal momento che, alzandoli, si fa il suo gioco ed è appunto nell'ascolto di chicchessia che esso ha il suo ubi consistam.
2 giugno 2020
La via di Paolo Fabbri
"Ora, così come nessun linguista accetterebbe l'idea che il linguaggio è fatto di parole, credo che nessun semiologo dovrebbe accettare l'idea che i sistemi di significazione sono fatti di segni. La semiotica, come la linguistica, dovrebbe semmai interessarsi al modo con cui attraverso una certa forma sonora (o altrimenti significante) noi produciamo sistemi e processi di significazione, ossia siamo in grado di significare mediante un certo tipo di organizzazione (fonetica, iconica, gestuale etc.). Il che porta a modelli esplicativi che non hanno nulla a che vedere con sommatorie di parole. La lingua non è una somma di parole, e un sistema di significazione, a sua volta, non è un insieme di segni".
Distante o prossima, correva a tratti parallela, la via di Paolo Fabbri. Una via non sempre perspicua, va detto. E il suo passo, talvolta, poteva parere ingenuo (come si intravede del resto anche nel piccolo brano appena citato). D'altronde, se mai da parte di Paolo c'è stato interesse per Apollonio Discolo e per il suo alter ego (al di là del prezioso svelamento anagrammatico che con "Apollo col Dioniso" procurò al nome di chi scrive questo diario), chissà quante volte i loro passi sulla loro via gli saranno parsi anche più ingenui, malfermi e infantili.
31 maggio 2020
Intolleranze (12): "Borghi"
I centri abitati di provincia, piccoli e medi, spesso antichi, che fuori di poesia un dì si designavano pianamente e con schiettezza come paesi o cittadine, c'è da temere diventino metropoli, se vi si trasferirà, come dice di avere intenzione di fare per istigazione di qualche furbo che ha annusato l'affare, tutta la gente già "zotica" che da qualche tempo ha cominciato a chiamarli borghi, con comica e sussiegosa affettazione.
25 maggio 2020
22 maggio 2020
Linguistica da strapazzo (45): "Abbiamo perso la generazione dei nonni..."
Non c'è morte che non sia degna di considerazione e di rispetto. Come ogni nascita, del resto. Ma non è qui questione di vita o di morte ed è invece futilissima questione di lingua, cioè di espressione e di comunicazione.
"Abbiamo perso la generazione dei nonni..." sente dire sovente e pubblicamente Apollonio da qualche settimana, per via di una vicenda di cui scrivere ancora solo un rigo suonerebbe oltraggioso per i due lettori di questo diario.
Sotto ogni profilo correlato al contesto (o alla realtà, se qualcuno preferisce), quindi quanto a funzione referenziale, anche tenendo in conto le variazioni diatopiche dell'incidenza degli esiti letali del morbo, l'affermazione e il correlato atto comunicativo sono palesemente destituiti di ogni fondamento. Apollonio incluso, i vecchi e le vecchie ovunque in Italia erano e restano in numero altissimo, non solo in cifra assoluta, ma anche (e più indicativamente) in percentuale. La generazione dei nonni e delle nonne (per designare l'insieme figurativamente, visto che i e le nipoti scarseggiano) presidia le sue posizioni, a ranghi solo molto debolmente rarefatti. E la memoria, del cui destino una nazione sembra d'improvviso tartufescamente preoccupata, è salva (sempre che la demenza senile non l'attacchi).
Esclusa la pertinenza referenziale, credibile è invece che l'atto prenda valore rispetto alla funzione emotiva e voglia trasmettere, secondo una modalità espressiva tipica dei funerali, una partecipazione molto sentita di chi così si esprime a proposito d'una vicenda che non descrive, ma sulla quale con quelle parole favoleggia.
Se di favola si tratta o, come usa dire adesso, di racconto e di un racconto emotivamente orientato, diventa opportuno considerare l'atto sotto il profilo conativo, cioè in funzione di chi ne è destinatario o destinataria. Vista la manifesta infondatezza referenziale, a costoro si chiede di sospendere la loro incredulità: di "bersela", in altre parole, senza stare troppo a pensare non tanto alla falsità, quanto persino all'inverosimiglianza della favola.
E si è così al punto. Trattandosi di atto comunicativo che comporta una sospensione dell'incredulità da parte di chi lo riceve, "Abbiamo perso la generazione dei nonni..." è mera letteratura e va valutato con riferimento alla funzione poetica: messaggio che trova la sua ragione d'essere in se stesso.
Come figura, l'enfasi è la sua cifra, ma nulla più dell'enfasi è da maneggiare con molta cautela per la confezione di un testo di buona qualità letteraria e basta poco per mostrarlo. Basta ricordare, tra i tanti altri comparabili, il caso quantitativamente esemplare di "Otto milioni di baionette", anch'esso infondato dal punto di vista referenziale e fondato invece non tanto sopra una richiesta, quanto sopra un'imposizione di sospensione dell'incredulità. Volgarità, come s'intende: l'enfasi è infatti quasi sempre marca di una letteratura molto scadente e da trivio, anche al di là delle differenze politiche tra richiesta e imposizione, tutt'altro che chiare perlomeno da un secolo a questa parte.
Proprio per rispetto dei morti, pochi o tanti che siano stati, della sguaiataggine delle enfasi bisognerebbe allora fare a meno. Sarebbe però come chiedere di tacere alla temperie ignobile di una modernità ormai putrefatta. Cioè, in fin dei conti, come chiederle di non essere se stessa.
18 maggio 2020
"Riccardino"
La forma dell'acqua, Il cane di terracotta, Il ladro di merendine, La voce del violino, La gita a Tindari, L'odore della notte, Il giro di boa, La pazienza del ragno, La luna di carta, La vampa di agosto, Le ali della sfinge, La pista di sabbia, Il campo del vasaio, L'età del dubbio, La danza del gabbiano, La caccia al tesoro, Il sorriso di Angelica, Il gioco degli specchi, Una lama di luce, Una voce di notte, Un covo di vipere, La piramide di fango, La giostra degli scambi, L'altro capo del filo, La rete di protezione, Il metodo Catalanotti, Il cuoco dell'Alcyon. E per chiudere con il commissario Salvo Montalbano, adesso, Riccardino, annunciato già da un quindicennio.
Andrea Camilleri è sempre stato un fenomeno, in più d'uno dei valori che ha la parola fenomeno: umanamente fenomenale, ma anche fenomenico, manifestazione osservabile di uno stato della lingua (letteraria) nazionale e, quanto al ceto intellettuale d'espressione italiana, della tendenza ad allinearsi ai luoghi comuni (deriva che, quando si verifica in politica, viene detta populismo).
L'alter ego di Apollonio, è stato un lettore di Andrea Camilleri se non costante, lungamente fedele e divertito, ma divertito solo fino a un certo punto. Qui, qui e qui, per chi vuole, ancora tre testimonianze, la prima risalente all'inizio di questo secolo. Un lettore sempre distante, perché convinto che lo sguardo da lontano appreso in una stagione ormai perenta di una formazione umanistica, preserva dall'appiccicaticcio di plausi zuccherosi e dalle pacchiane enfasi di apoteosi fuori misura. Anche quando tale sguardo è affettuoso, anzi tanto più quando è affettuoso, come non può non essere per via di un'infanzia e di una parte dell'adolescenza trascorsa dall'osservatore proprio nei pressi di Vigata e di Montelusa.
Per distante affetto, Apollonio vuole crederlo, come lo crede il suo alter ego: gli zuccheri e le enfasi della tardiva, sbardellata fortuna di Camilleri non potevano del resto non sembrare comici e, a tratti, proprio ridicoli al figlio di un uomo che ogni mattina sentenziava "Accuminzamu cu nova prumissa sta gran sulenni pigliata pi fissa", avendone ben donde, quell'uomo, perché attivamente partecipe, tanto in gioventù quanto più avanti negli anni, a solennissime, ventennali turlupinature ai danni di una nazione intera mandata conseguentemente a remengo.
E, a segnalare un'adesione sardonica (sardonica, come a una sortita del genere l'adesione non può non essere), Camilleri trasferì pari pari il motto dal padre reale alla propria creatura letteraria: Salvo Montalbano. Ne ha così fatto, tra le righe, l'ammiccante portabandiera della sua poetica in atto: la poetica del tragediatore, in tal modo Camilleri qualificò la sua funzione, al suo esordio, qualificazione cui mise in séguito e opportunamente la sordina. Funzione, il tragediatore, tanto più beffarda quanto meno lo pare. E funzione lontana da quella poetica consolatoria piattamente dichiarata e dichiaratamente richiestagli per glorificarlo da una temperie conformista e ostentatamente sentimentale come la presente che, come stanno mostrando circostanze anche recentissime, non solo vuole essere spudoratamente presa per i fondelli, ma non tollera che qualcuno le segnali anche solo la possibilità che lo sia.
Dopo Pier Paolo Pasolini e Leonardo Sciascia, non c'è stata più peraltro una figura pubblica della scena letteraria e intellettuale italiana capace di andare di bolina. Si rimprovererà a Camilleri, giunto già anziano e per onesta fortuna alla fama e ai correlati agi per sé e famiglia, di avere da quel momento dedicato la giusta attenzione a garantirsi il vento in poppa?
Dopo Pier Paolo Pasolini e Leonardo Sciascia, non c'è stata più peraltro una figura pubblica della scena letteraria e intellettuale italiana capace di andare di bolina. Si rimprovererà a Camilleri, giunto già anziano e per onesta fortuna alla fama e ai correlati agi per sé e famiglia, di avere da quel momento dedicato la giusta attenzione a garantirsi il vento in poppa?
Con l'uscita a breve di Riccardino, si vedrà allora cosa il tragediatore, con una lunga preparazione e una premeditazione molte volte dichiarata, ha escogitato per congedare post mortem la sua popolarissima creatura, cui deve tutto a conti fatti, liberato soprattutto il campo dalle larve di alcune sue patenti velleità sciasciane e manzoniane. Le si dicono velleità a ragion veduta. Sono infatti frutti di una vena elegiaca. E l'elegia è l'opposto della consapevolezza del tragico che sta sul fondo di ogni commedia umana e che, in misure diverse, ispirò Manzoni e Sciascia. A chi vuole, una semplice misura del genere serve anche a comprendere quanto in realtà l'opera di Camilleri sia spiritualmente (oltre che formalmente) lontana da quella di Georges Simenon, anche lui autore tragico.
La lettura del primo capitolo del tanto atteso Riccardino procurata l'altrieri in rete, come anticipazione, da Antonio Manzini promette un Camilleri autentico, non quello posticcio che la discutibile delega alla scrittura imposta all'autore dalla cecità e da esigenze editoriali aveva fatto circolare con le ultime uscite della serie del commissario. Al bravo e volenteroso Manzini e ai suoi ascoltatori non siciliani va marginalmente segnalato che filinie suona filìnie e non filinìe e Inzolia suona Inzòlia e non Inzolìa. Si sorvola, per non risultare ulteriormente pedanti, sull'accentazione di qualche infinito. Del resto, al camillerese in bocca romana si è ormai largamente accostumati: a suo modo, è spezia indispensabilmente costitutiva della burla.
Ciò che è certo (e già da un po') è che, con Riccardino, la foggia del principale elemento della soglia (per dirla con Gérard Genette) muta. L'elenco in apertura è loquace, con le sue scarse eccezioni al modulo Articolo + Nome + Preposizione (articolata) + Nome. Dopo tanti titoli costruiti insomma come nessi nominali complessi a echeggiare non di rado frasi fatte e luoghi comuni, ecco apparire, secco e misterioso, il vezzeggiativo di un nome proprio, privo inoltre di connotazioni regionali: Riccardino, appunto. Bisognerà attendere di avere sotto gli occhi il libro per intero, per provare a capire, ove non fosse apertamente spiegata dal tragediatore, una frattura così palese, così drammatica.
Il pensiero corre tuttavia liberamente a quel Riccardin (dal Ciuffo) che, per tradizione italiana, corrisponde al Riquet (à la Houppe) della fiaba popolare francese ripresa da Charles Perrault. La fiaba narra di un principino brutto e pieno di spirito, destinato, per compensativo dono di una fata, a trasmettere la sua intelligenza a colei che amerà. E narra di una vicina principessa bellissima e tonta, destinata, per complementare dono della medesima fata, a trasmettere la sua bellezza a colui che amerà. Dice infine del loro innamorato incontro e delle rispettive metamorfosi, per reciproco e fatato influsso. Incanto? Niente di più di quanto non faccia quotidianamente l'amore, chiosa l'ironico autore francese. Agli occhi dell'innamorato, una svampita pare colma di spirito e uno sgorbio pare un adone, agli occhi dell'innamorata: "Tout est beau dans ce que l'on aime, tout ce qu'on aime a de l'esprit".
Ecco, appunto: una grande, fiabesca storia d'amore è quanto c'è stato tra il tragediatore faceto e la sua plaudente e affollata piccionaia.
11 maggio 2020
Cronache dal demo di Colono (64): Paideia, in caricatura
Ora che in TV, reti sociali e media comparabili la cultura umanistica straripa e spesseggiano le sue maschere del momento, è tempestiva e divertente la personificazione che ne ha fatto Corrado Guzzanti, con una maschera ideale: l'umanista da videocamera. Ecco un suo fresco intervento in una trasmissione televisiva di infotainment al momento molto fortunata.
Gli sproloqui talvolta sussiegosi, talaltra piacioni dei personaggi di questa giostra e le sesquipedali corbellerie del Lorenzo di Guzzanti hanno in comune molti tratti: perentorietà dell'approssimazione, brama di stupire, furbesco ammiccamento, presenzialismo compiaciuto, mozione dei sentimenti, gusto per l'iperbole, evocazione di luoghi comuni e loro incessante rimescolamento.
Guzzanti ha fiuto, come si sa, e la sua caricatura coglie caratteri pertinenti del tipo umano e della situazione comunicativa. Li amplifica e li porta verso il comico e il morale, come del resto usa da sempre la satira.
Prima di andare in video, molti e molte guadagnerebbero in consapevolezza, se fossero capaci non solo di guardarsi, ma anche di riconoscersi in questo specchio. Lungi dall'essere deformante, esso traccia con esattezza qual è la forma in cui entrano, qualunque cosa siano eventualmente in grado di dire.
Gli sproloqui talvolta sussiegosi, talaltra piacioni dei personaggi di questa giostra e le sesquipedali corbellerie del Lorenzo di Guzzanti hanno in comune molti tratti: perentorietà dell'approssimazione, brama di stupire, furbesco ammiccamento, presenzialismo compiaciuto, mozione dei sentimenti, gusto per l'iperbole, evocazione di luoghi comuni e loro incessante rimescolamento.
Guzzanti ha fiuto, come si sa, e la sua caricatura coglie caratteri pertinenti del tipo umano e della situazione comunicativa. Li amplifica e li porta verso il comico e il morale, come del resto usa da sempre la satira.
Prima di andare in video, molti e molte guadagnerebbero in consapevolezza, se fossero capaci non solo di guardarsi, ma anche di riconoscersi in questo specchio. Lungi dall'essere deformante, esso traccia con esattezza qual è la forma in cui entrano, qualunque cosa siano eventualmente in grado di dire.
3 maggio 2020
"Verbi servili"
Potere, dovere, volere: "verbi servili". Al di là della vizza terminologia grammaticale, chissà se allo spirito di coloro che sono usi designarli così si è mai presentato il sospetto che la qualificazione suoni invece molto appropriata al loro uso discorsivo. Potere, dovere, volere: servili perché ne abbondano la parola di chi si fa servo e, naturalmente, quella di chi volentieri lo asservisce.
1 maggio 2020
"...non perché vogliamo sostituirci alla scuola che c'è..."
"...non perché vogliamo sostituirci alla scuola che c'è...", dice più o meno così una voce autorevole di Radio 3 nel corso di un sermoncino mandato in onda in questi giorni, a cadenze regolari. Il discorsetto illustra l'offerta di trasmissioni cui l'emittente radiofonica annette un valore didattico.
Come si sa, nella presente temperie, si è prontamente individuato nella scuola che c'era un istituto sociale (e morale) da sottoporre a una restrizione rigidissima: la si è chiusa. Sia chiaro: lo si è fatto con le migliori intenzioni.
Se un atto di portata sociale è accompagnato da un discorso, si dica però cosa nel mondo non si sia fatto con le migliori intenzioni, perlomeno da Costantino il Grande in avanti, con qualche retorica verecondia. E, con parole prive di remore, dalla Rivoluzione francese in avanti: migliori intenzioni a volontà.
Poi, se le intenzioni sono veramente le migliori o, migliori o no che siano, cosa da esse sortisce sono faccende di cui ai sedicenti meglio intenzionati cale di norma pochissimo. Chi vivrà vedrà e, fatte buone, anzi, migliori le intenzioni, cosa altro c'è da fare per avere la coscienza a posto? Andasse male (capita più spesso di quanto ci si immagini), c'è sempre, assolutorio, un "noi credevamo...".
E va detto: se in una fase perigliosa la scuola che c'era è stata forse il primo e l'unico istituto sociale (e morale) a essere destinato a uno schianto, è difficile pensare che, per i criteri correnti, non meritasse uno schianto. Quando c'è il rischio di affondare, ci si libera anzitutto di ciò che si giudica zavorra. La scuola com'era aveva un compito? Certo. Lo dice il dibattito corrente: quanto al graduale ritorno verso la normalità, permanendo chiusa la scuola, emerge chiaro un solo problema. Rappresentato dalla domanda "E allora i pupi, a noi, chi ce li tiene?", cui con fantasia apertamente disneyana risponde la promessa di un generalizzato bonus Mary Poppins.
Per sopravvivere nella procella "del tempo del Coronavirus", secondo una formula oggi vieta, le migliori intenzioni hanno così avviato la scuola che ci sarà verso pratiche massimamente omogenee e standardizzate, se non nei contenuti, certo nelle procedure: "Bisogna si fronteggi un'emergenza". Alla bisogna, ecco pronti radio, TV e media diversi. E siccome - lo si sa - questi non sono certo ecosistemi favorevoli alla sobrietà delle litoti, è tutto un fiorire di sgargianti iperboli: "maestri" discesi direttamente dalle accademie più esquisite, contenuti avvincenti e "imperdibili", lezioni come "eventi". Così racconta la propaganda. Altro che la misera scuola dei banchi rotti, della precarietà di professori e professoresse con titoli avventurosamente acquisiti, dei muri scrostati e delle improbabili aule di scienze, delle biblioteche con quattro libri da quattro soldi tenuti per giunta sotto chiave e dei bagni generalmente sudici. Futura (quindi finta), ecco la migliore tra le scuole possibili in un mondo che magari buono non sarà, ma è il presente che prefigura il futuro e sarà certo il migliore dei mondi possibili. Non buono, appunto, ma il migliore dei possibili.
Che l'operazione didattica stia andando bene o male non è il punto. In proposito, va detto con un amaro sorriso che talvolta il torpore, l'inattitudine, la vischiosità sono i soli modi naturali con cui l'umanità fa resistenza a un'ideologia degradante che fa dell'efficienza un valore morale assoluto e dell'efficacia un esclusivo criterio di giudizio. E, tra gli altri, Zygmunt Bauman ha mostrato quali possono essere e, fuori delle ipotesi, storicamente furono e ancora sono le velenose fonti a cui si abbevera un credo siffatto.
Del resto, in un momento che è difficile dire sia crepuscolo, alba o (più credibilmente) né l'uno né l'altra, alla luce in ogni caso radente del pensiero critico della modernità matura e tarda, tutto quanto sta accadendo è così chiaro e scontato, che Apollonio ha a tratti il sospetto di sognare, tante e tali sono le ipotesi elaborate da quel pensiero che la realtà sta adesso corroborando. La stupidità non può fare nulla per non somigliare al volto protervo che, in ogni tempo, ne ha illuminato il flash di qualche rado e fulmineo apparire dell'intelligenza.
Quando si sente della scuola e delle sue nuove procedure che, se ne può stare certi, sopravviveranno alla contingenza, banalmente "il medium è il messaggio" si avrebbe allora voglia per esempio di ricordare a chi pensa o fa sembiante di pensare che scuola "in-praesentia" e "dal-vivo" e scuola "non-in-praesentia" o "non-dal-vivo" vadano considerate varianti della medesima istanza sociale e morale o (che è lo stesso) a chi si esercita dottamente nel comico gioco di dire quale è meglio e quale è peggio, cosa è e sarà più pregevole nell'una e cosa nell'altra.
A sua volta, l'apertura di un celebre scritto del 1925 di Sigmund Freud reca un'ottima chiave per intendere le parole in esordio del presente frustolo. I due lettori di questo diario avranno già capito: è Die Verneinung, titolo che, sia detto di passaggio, ad Apollonio parrebbe reso con La denegazione forse meglio di quanto non lo sia con il corrente La negazione.
Nella traduzione di Elvio Fachinelli, quell'apertura suona così: "Il modo in cui i nostri pazienti presentano le loro associazioni durante il lavoro analitico ci fornisce lo spunto per alcune osservazioni interessanti. «Ora Lei penserà che io voglia dire qualche cosa di offensivo, ma in realtà non ho questa intenzione». Comprendiamo che questo è il ripudio, mediante proiezione, di un'associazione che sta or ora emergendo. Oppure «Lei domanda chi possa essere questa persona del sogno. Non è mia madre». Noi rettifichiamo: dunque è la madre. Ci prendiamo la libertà, nell'interpretazione, di trascurare la negazione e di cogliere il puro contenuto dell'associazione".
"...non perché vogliamo sostituirci alla scuola che c'è...". Ecco: in una formula che, ripetuta meccanicamente centinaia di volte, si vuole evidentemente penetri nelle teste di chi la ascolta, come un mantra, basta appunto si trascuri la negazione. Si saprà così quale intenzione abbia il futuro, quello cui l'espressione appartiene veramente e che mette le sue parole sulla bocca di un portavoce crudo e forse inconsapevole. Proclamando presente una scuola che manifestamente non c'è, questo dichiara appunto che non la si vuole sostituire. Dichiara che non si vuol fare, insomma, ciò che si sta evidentemente sognando di fare e che in parte si è già fatto.
26 aprile 2020
24 aprile 2020
Cronache dal demo di Colono (63): "Ravvedetevi"
Non la pacata e riflessiva osservazione di ciò che concretamente, incessantemente e ineluttabilmente muta (testimone, la medesima vita umana), ma il cambiamento in sé, come un feticcio cui si deve un culto mistico, è tratto specifico della forma di civiltà che pare oggi non risparmiare più nessun angolo del mondo, diffusasi come si è, nei secoli, prima per lenta, poi per rapidissima epidemia.
I riti imposti da quel culto chiedono scenari continuamente cangianti e, lungi dal distrarre l'osservatore spassionato (cioè, etimologicamente, lo storico, se non per professione, per attitudine), il turbinio gli offre ottime condizioni per una prova, la cui messa in atto viene scambiata dai fedeli di quel culto per manifestazione di spirito retrivo, quando, semmai, è propriamente il contrario, dal momento che è un modo di verificare quanto di sostanziale e quanto di meramente fenomenico ci sia nel cambiamento.
Non è nuova, ma vale la pena sia ribadita l'osservazione che, pur nel mutare degli scenari, non le persone, che sono effimeri tokens, ma i personaggi, che sono durevoli types, con le loro attitudini e i loro modi (umani) di condursi, sono caratterizzati da tratti che si ripetono. Ed è suggestivo pensare, passando dalla diacronia all'etologia, che gli atti scenici che ne conseguono siano determinati in modo decisivo da una sorta di coazione a ripetere, tragica talvolta, talaltra comica, sempre, vista la sua evidenza, impudicamente esibita.
Un caso esemplare, nella presente temperie, è recato dalla diffusissima attitudine alla predica profetica. La scena pubblica e, in modo debordante, il palcoscenico intellettuale conta oggi mille e mille predicatori e predicatrici, che sgomitano alla ricerca di ascolto.
Nella ressa, s'alzano le loro voci che ingiungono a chi le ode ravvedimento e cambiamento (di stile) di vita, che dichiarano l'esigenza universale di mondarsi e, mondandosi, di mondare il mondo, che invitano a muoversi verso nuove terresante in un comunitario pellegrinaggio, meglio se non proprio inerme, come pellegrinaggio, visto che, sulla strada, non è detto si manchi di incrociare qualche infedele.
Non c'è àmbito della società globale che al momento sia immune da prediche profetiche e ammonitrici e nello spettacolo, ripetitivo e quindi fondamentalmente noioso, bisogna che si ammetta che, forniti da qualche guitto, ci sono qui e là sprazzi esilaranti.
23 aprile 2020
Dare i numeri senza averli
Sulla lingua, persiste una depressione ciclonica. Chetatasi la procella delle pubbliche fustigazioni grammaticali, adesso piovono glosse a catinelle. La stagione le incoraggia, quasi le richiede e non c'è chi, professionista o dilettante della penna, dimessi i panni di Aristarco, non abbia rapidamente preso quelli di uno Spitzer. Resa acuta in tal modo la propria matita, si è messo o messa a chiarire il trasparente uso di metafore cristalline, a dipanare derivazioni lessicali rettilinee, a spiegare arcane antifone da asilo nido. Questo va del resto sul mercato delle idee e guai a non assecondare il mercato: "il mercato" è la prosopopea di una tirannia e non si sa il tiranno, ma certo i suoi pavidi e interessati lacchè mal sopportano che lo si contraddica o che ci sia qualcuno che, al suo cospetto, faccia spallucce e, sovversivo, gli giri le spalle.
È così che si è appreso, tra l'altro, che quanto sta accadendo, malgrado se ne parli come di una guerra, non è una guerra, anche se, in figura, potrebbe esserlo e forse ineluttabilmente lo è. È così che si è capito cosa veramente significa quello "stai buono e composto o viene l'orco e ti mangia" che non manca momento non rimbombi in celle i cui reclusi e le cui recluse tollerano qualsiasi cosa, ma non che qualcuno o qualcosa venga a ricordare loro l'unico vero e ineludibile obbligo contratto con l'atto neppure volontario, chissà se intenzionale, di venire al mondo. Insomma, tutta roba che, non ci fosse chi la porta alla luce, non si sa come farebbe la società locale e globale a essere consapevole di sé medesima in un momento tanto critico.
Se questo è lo stato in cui versa oggi la metalingua, i due lettori di Apollonio saranno clementi con lui. Al diluvio questo diario aggiunge infatti una lacrima: si tranquillizzino, effetto del ridere. Sarà la goccia che farà traboccare il vaso della loro pazienza? Forse. Ma il danno sarà limitato dal sottovaso del loro affetto per il vecchio Apollonio, che appartiene a un categoria a rischio, ma che, con le due raffazzonate nozioni apprese da autodidatta, è lui piuttosto un rischio, pur se modestissimo, per la categoria.
Tanti e tante, come si diceva, parlano incessantemente di parole. E da dove le parole vengono. E cosa significano. E come si usano. E come andrebbero usate. E che fini perseguono. E che conseguenze avranno o potrebbero avere. E così via. Come se, nel discorso a una dimensione che si è oggi impadronito della totalità dello spazio pubblico in maniera appunto e propriamente totalitaria, la cosa più importante fosse quanto si presenta sotto la forma di parole. Non è così, invece, a parere di Apollonio. A caratterizzare quel discorso, a qualificarlo in modo pertinente non sono le parole, qualunque esse siano, ma sono i numeri.
Qui, bisogna che i due lettori di Apollonio facciano attenzione, per non rimanere, almeno loro, vittime di un luogo comune inveterato. Non solo inveterato, ma tra quelli che, da qualche secolo, impediscono che delle cose morali, concretamente morali del mondo, si abbia una percezione ragionevole. Ci si sta riferendo al luogo comune che vuole in contrasto numeri, valorizzati positivamente come certi e affidabili, e parole, valorizzate negativamente come approssimative e inaffidabili.
Intendiamoci: giudizio di valore, ciascuno dà il suo e qui non si insiste un solo momento sulla questione. Libere opinioni. Ciò che il luogo comune nasconde o distorce non è però un'opinione, è un fatto. E nascondere o distorcere fatti è falsa coscienza o ideologia, dicevano due acuti osservatori che, ora è un secolo e mezzo, di come stesse già procedendo la società dell'Evo moderno s'erano fatta qualche penetrante idea, magari sbagliata. Ma, come ripeteva ad Apollonio in anni ormai lontani una persona a lui carissima, è meglio avere idee sbagliate che non avere idee del tutto.
Cosa cela allora la prospettiva che, nel discorso, vuole numeri e parole irriducibilmente diversi? Cela il fatto che nel discorso in genere e ancor più nel discorso pubblico, non c'è niente, non può esserci proprio niente che non sia parola, in ultima e fondamentale istanza. Insomma, non c'è nulla che non soggiaccia al sistema del discorso. Se numeri vi ricorrono, dunque, come ricorrono in effetti e in maniera ossessiva nell'odierno discorso pubblico, si tratta in modo lampante di parole vestite o, meglio, mascherate da numeri.
È questo un elementare dato di realtà, della realtà linguistica, dello stato dei fatti linguistici; realtà, stato dei fatti assoggettabile a osservazioni sperimentali e alla formulazione di ipotesi che provino a renderne conto allo stesso titolo di come si fa con ogni altra realtà, con ogni altro stato dei fatti, mutando ovviamente ciò che c'è da mutare quanto al metodo. Ogni seria prospettiva osservativa ne ha infatti uno suo proprio: insostituibile e talvolta frutto di pratiche faticose e secolari. Ce l'ha persino la linguistica, a proposito della quale Apollonio non si nasconde il dubbio possa sul serio essere qualificata, tra le discipline, come seria.
Ancora una volta, però, attenzione, pazienti Lettori. Dei numeri presenti nel discorso, non si sta qui dicendo che si può discutere in quanto numeri (cosa peraltro ovvia, dovunque i numeri sono eventualmente numeri e basta: sempre che un contesto siffatto esista). Si sta dicendo una cosa più specifica, linguisticamente. Si sta dicendo che se ne può discutere per ciò che sono nel discorso: cioè per il loro valore di forme superficiali di parole. Se ne può quindi discutere proprio in quanto parole che si presentano come numeri, con tutti i correlati effetti discorsivi. Un discorso con parole che compaiono come numeri soggiace infatti, come ogni altro discorso, ai modi costitutivi e di sviluppo del discorso e, nel discorso, i numeri possono mentire esattamente come possono farlo, dandosi il caso, le parole. Ma, di nuovo, è questa un'ovvietà di cui non si vuole fare qui la minima questione. Solo i gonzi (incoraggiati a essere tali da altri gonzi o da furbi imbroglioni) possono credere che chi, nel suo discorso, mette tante parole travestite da numeri sia perciò stesso esente dal sospetto d'essere un millantatore, un imbroglione, un mentecatto. La cruda e penetrante ingenuità della lingua possiede in proposito una locuzione rivelatrice: dare i numeri.
Interessante è in ogni caso osservare che, linguisticamente, una cosa è parlare per parole mascherate da numeri, una cosa diversa è parlare mescolando parole e parole vestite da numeri, una cosa ancora diversa è parlare solo per parole. In scelte siffatte, ci sono infatti valori diversi e bisogna evitare di cadere nella trappola del vieto e malandrino "I numeri parlano da sé": Apollonio sa di parecchi malfattori che non si servono di questa formula, ma non sa di nessuno che se ne serva che non sia un malfattore. Pericoloso, aggiungerebbe.
Nei discorsi, i numeri, come maschere delle parole, non hanno mai parlato da sé. Se dicono qualcosa, a chi li sa osservare criticamente, dicono al massimo che sono forme che celano parole e che le relative parole sarebbero magari in apparenza più vaghe, ma sarebbero almeno parole smascherate. O cui si potrebbe togliere più facilmente la maschera. La parole mascherate da numeri hanno infatti maschere corazzate. Avanzano con violenza, quando si tratta di contrasti, e non fanno prigionieri: le parole prive di maschere e inermi ne vengono di norma sterminate.
Se, giunti a questo punto, i due pazienti Lettori provano a figurarsi l'oceano di discorsi caratterizzati da numeri in cui da decenni si trovano immersi come destinatari; se si accorgono come tale oceano, nella presente temperie, sia divenuto ben più che tempestoso e, da dove dovrebbero giungere parole, arrivano loro addosso numeri a ondate gigantesche e contrapposte; se osservano che si tratta di numeri tanto irragionevoli e spaventosamente grandi o, quando di taglia accettabile, tanto assoluti e privi dello sfondo che li qualifichi, da risultare completamente incomprensibili, tranne che nella loro funzione di opachi involucri di parole; se insomma, a mente sgombra e per un momento, riflettono sullo stato presente della comunicazione e della soggiacente espressione, Apollonio è certo che non potranno non concordare con lui. Stare a fare chiacchiere sulle parole, sulle metafore e sulle etimologie, sulle inferenze e sugli impliciti e così via, pensando così di cogliervi chissà quale essenziale spirito del tempo è gingillarsi, se mai è stata cosa diversa.
Oggi le sole parole che contano (ed è facile gioco di parole) sono i numeri. E il discorso pubblico della modernità putrefatta (pubblico e totalitario, c'è da precisare) non fa altro che dare i numeri. Li dà senza tregua, parossisticamente e a dosi sempre più massicce. Li dà in modo da instupidire, da stordire chiunque lo ascolti. Dà i numeri (ed è questo l'aspetto più comico della faccenda) senza avere i numeri per darli, cioè senza il fondamento di quel pensiero umano ragionevole fatto di parole libere che non c'è numero possa mascherare. O, forse, che non c'era numero potesse mascherare.
Iscriviti a:
Post (Atom)