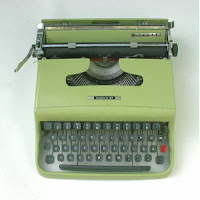Un giorno, a Ginevra, Ferdinand scrisse un appunto che diceva quanto segue. Per uscire dal circolo vizioso in cui si trovano da sempre i discorsi sulla lingua (nessuno escluso), è indispensabile sostituire, una volta per tutte, la discussione dei «fatti» (scrisse proprio così, usando le virgolette) con quella dei punti di vista, perché "non c'è la minima traccia di
fatto linguistico, la minima possibilità di cogliere o di determinare un fatto linguistico fuori dell'adozione preliminare di un punto di vista".
L'articolo di Paola Mastrocola
"L'italiano una lingua in coma", oggi sulla
Stampa (nel giornale in edicola, pare, addirittura in prima pagina), parla di lingua. Di professione insegnante e scrittrice, l'autrice vi illustra il lamentevole stato in cui versa la didattica linguistica nelle istituzioni scolastiche italiane: come darle torto? Del resto, geremiadi di tenore comparabile sono comuni in ogni epoca. Diventano ancora più comuni in quelle critiche (la presente pare tale) e soprattutto sotto la penna dei titolari di matita rossa e blu, cui spetta d'elezione additare la decadenza dei costumi (linguistici). Il pezzo propone del resto anche misure per fare fronte allo stato della calamità culturale che descrive e, anche lì, poco da dire: chi non approverebbe una scuola che volesse insegnare di più, anche più grammatica, a chi la frequenta appunto per imparare?
Un dubbio, a dire il vero, qui resterebbe. Di insegnare più grammatica fuori delle ore canoniche di lezione, secondo la Mastrocola, si dovrebbero far carico "i giovani precari disponibili". Ora accade che, nei loro studi superiori, la grammatica non è stata insegnata neanche a costoro (né alla stragrande maggioranza dei loro colleghi con posto fisso). C'è da chiedersi se tanti di loro passerebbero il test linguistico di ingresso che la Mastrocola propone per gli studenti che s'iscrivono alle superiori. Per carità di patria e per tenersi al tono edificante (e in fondo corporativo) dello scritto, tale dubbio può però essere qui messo a tacere.
Quando la Mastrocola, in un passaggio decisivo, scrive però "vorrei timidamente avvertire che ci sarebbe un problemino da risolvere con urgenza:
il fatto che i ragazzi hanno
di fatto perduto la conoscenza della lingua italiana" (i corsivi sono di Apollonio), la questione del rapporto tra "fatto" e punto di vista si presenta in tutta la sua evidenza.
Come sanno i suoi due lettori, Apollonio vive nella sua Citera e del mondo poco sa. Dal poco che sa, però, il fatto non gli risulta. Non gli risulta che i giovani italiani siano diventati d'improvviso alloglotti e che, invece della lingua neolatina che sta in bocca ai loro genitori, parlino e scrivano inglese o cantonese, poniamo. Tanto meno gli risulta che siano tornati all'espressione dialettale dei loro bisnonni (magari fosse così! Si potrebbe snobisticamente dire, per certi aspetti).
Cosa significa allora che la Mastrocola dica che è un
fatto che
di fatto i ragazzi hanno perduto la conoscenza della lingua italiana? Significa che si esprimono in un italiano scolasticamente inadeguato, in un italiano che non è tale
dal suo punto di vista di professoressa. L'articolo non sta parlando di un fatto, dunque, tanto meno lo sta descrivendo. Sta parlando di un punto di vista (da cui l'esistenza del presunto fatto dipende) e lo sta illustrando con l'appoggio di un'evidenza spacciata per assoluta, perché non ne è reso chiaro l'implicito punto di vista.
Ci si occupi della prassi e non delle prediche. Non condividono il punto di vista della professoressa attori sociali numerosi e rilevanti: tutti i mezzi di comunicazione di massa, per es., che per rivolgersi ai giovani si esprimono ovviamente in italiano (non in cantonese né in dialetto; qualche volta, è vero, in inglese) e in un italiano che è condiviso, per necessario presupposto comunicativo. Si pensi alla pubblicità (e di conseguenza a giornali, televisioni ecc., che ne sono semplici emanazioni): chi getterebbe tanti soldi, per non farsi capire? Sarebbe allora interessante sapere se, per la Mastrocola, di fatto, non sia italiana neanche l'espressione dei
media e di tutto il complesso sociale ed economico che i
media rappresentano, quando si rivolgono ai "ragazzi".
Un esempio: ad Apollonio viene sovente fatto di pensare che chi scrive sulla
Stampa di Torino non conosce l'italiano e sogna di suggerire, conseguentemente, corsi di recupero linguistico per redattori e collaboratori. La consapevolezza che si tratta di un punto di vista tuttavia lo trattiene dallo scrivere una tale grossolanità, moderandola nell'affermazione di gusto personale che, sulla
Stampa, non si scrive in italiano come lui amerebbe si scrivesse, cioè seguendo quel costume e quelle norme di comportamento che egli ritiene adeguate a una scrittura giornalistica di qualità.
E così appare d'improvviso che la questione del rapporto tra "fatto" e punto di vista conduce a domande di una certa rilevanza non solo teoretica, ma anche operativa, anche morale. La Mastrocola vende il suo punto di vista come fatto; lo rende così assoluto, da poter concludere che bisogna "restituire ai giovani l'ancora prezioso e insostituibile dono della parola", quasi che i giovani italiani fossero d'improvviso divenuti tutti afasici (non sarà per caso la scuola a esser divenuta sorda?). Fa ciò certamente per il bene di tutti: i professori fan sempre tutto per il bene di tutti. È sicura però, e con lei si è tutti sicuri che l'italiano che lei immagina tale sia quello che garantisce non si abbiano difficoltà non tanto all'università (che sempre scuola è) ma "nella vita tout court..."?
A parte il fatto che a leggere articoli di notisti di grido del suo stesso giornale non parrebbe (i due lettori di Apollonio ne avranno memoria), non bisogna dimenticare che i "ragazzi" non conosceranno l'italiano (come vuole la Mastrocola) ma scemi non sono. Sentono parlare i loro insegnanti e i loro genitori, sentono la TV e (talvolta) leggono i (loro) giornali. Insomma, come "i bambini" del film di Vittorio De Sica, "ci guardano": per imitazione o per contrasto, fanno ciò che vedono fare, anche linguisticamente. I "ragazzi" sono diagnosi e prognosi della società adulta: le dicono da subito ciò che essa è e, in anticipo, ciò che essa sarà sul fondamento di ciò che è.
E d'altra parte, ammesso e non concesso che l'italiano cui pensa la Mastrocola sia indispensabile per avere successo nella vita, è sicura lei, si è tutti sicuri che, anche per insegnare l'italiano che a lei piace (che non è forse lo stesso che piace ad Apollonio), non sia anzitutto pedagogicamente necessario considerare, ascoltare e conoscere (con l'amorevolezza che richiede la passione per lo studio) non solo l'esplicito punto di vista di una professoressa che scrive articoli sui giornali ma anche, e per democrazia, quello implicito dei "ragazzi"?
Forse, costoro considerano italiano, il loro italiano, ciò che hanno sulla bocca e chissà come considerano ("una lingua in coma"?) la lingua che (di tanto in tanto) insegnano i loro professori, visto che la società che sta loro intorno parla la loro, di lingua, e parla poco o per nulla quella che la scuola pretende o si ricorda talvolta di avere.
Insegnare la grammatica, dice poi la Mastrocola. Ma quale? Quell'incomprensibile e astruso miscuglio di tautologie che neanche chi insegna capisce, tanto meno ama, con le quali si pretenderebbe di surrogare la pratica delle buone letture, delle buone conversazioni, della riflessione interiore sulla propria espressione? E poi, qualunque grammatica si voglia insegnare, per saperlo fare, bisogna anzitutto avere compreso che la grammatica è sempre comparativa: contiene sempre punti di vista da confrontare. Ciò varrebbe forse la pena d'insegnare, se lo si sapesse fare, per capire, prima di impancarsi a professori, la propria, di grammatica, e quella dei "ragazzi": perché anche l'espressione dei "ragazzi" ha una rigorosissima grammatica. Molti insegnanti lo ignorano, dal momento che non hanno mai studiato veramente grammatica né sanno cosa sia.
Non lo scopre certo Apollonio: insegnare è mestiere difficilissimo, ma non per le ragioni che normalmente adducono i sindacati degli insegnanti. Lo è perché mette continuamente chi lo pratica a repentaglio, incoraggiandolo, col possesso della matita rossa e blu, a diventare un ridicolo trombone, a prestare fede ai palloni che gli si gonfiano in capo, a credere di conseguenza all'esistenza dei "fatti", a prendere facili scorciatoie normative.
All'inizio del secolo scorso, Ferdinand era un professore di linguistica in un'università di provincia, teneva i suoi corsi e prendeva le sue note segrete (quella da cui si è partiti, la si conosce solo da pochi anni). Niente "fatti" senza punto di vista, pensava. Estremo degrado del relativismo culturale? Infelice e nichilista paradosso di un uomo fallito professionalmente e personalmente? No. Modesta misura di buon senso, spillo che fa esplodere i palloni pieni d'aria di cui la testa di tutti è incessantemente riempita, quella dei colti e competenti non meno (Apollonio direbbe di più) di quella degli incolti e incompetenti.
Mai trascurare i matti e i falliti. Anche della vita pulsante e quotidiana della società, oltre che dell'altro mondo, vedono cose che i savi di successo non vedono.
PS. Nel "compitino" in classe della Mastrocola, sotto la ripetizione di
fatto lo stupido e arcigno Aristarco che, ingabbiato e impotente, ruggisce mal represso in Apollonio avrebbe messo due segni rossi.
 Come i suoi due affezionati lettori sanno, ormai da qualche anno Apollonio ha eletto a dimora, sempre più esclusiva, una Citera interiore ma per nulla solitaria. Tiene lontano da essa, come può ma con cura, il suo povero affaccendarsi medesimo, oltre che l'altrui, la cui eco gli giunge fievole ma non tanto da non rendergli palese che, non solo nella sua disciplina ma nell'insieme di fenomeni sociali e culturali che riguarda la lingua (e l'italiano in particolare), c'è un rinnovato agitarsi.
Come i suoi due affezionati lettori sanno, ormai da qualche anno Apollonio ha eletto a dimora, sempre più esclusiva, una Citera interiore ma per nulla solitaria. Tiene lontano da essa, come può ma con cura, il suo povero affaccendarsi medesimo, oltre che l'altrui, la cui eco gli giunge fievole ma non tanto da non rendergli palese che, non solo nella sua disciplina ma nell'insieme di fenomeni sociali e culturali che riguarda la lingua (e l'italiano in particolare), c'è un rinnovato agitarsi.