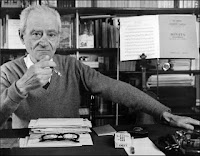"Chi siamo noi?": questione tenuta per profondissima da millenni. Così profonda da sprofondarne altre, candide e superficiali. Una in particolare, senza risposta alla quale c'è il fondato sospetto che le nuove risposte alla domanda profonda siano solo varianti delle solite: "E noi, cosa è?"
Dell'espressione, in una lingua non comune ("Mihi sic est usus; tibi ut opust facto face").
31 gennaio 2016
Linguistica candida (34): "Chi siamo noi?"
"Chi siamo noi?": questione tenuta per profondissima da millenni. Così profonda da sprofondarne altre, candide e superficiali. Una in particolare, senza risposta alla quale c'è il fondato sospetto che le nuove risposte alla domanda profonda siano solo varianti delle solite: "E noi, cosa è?"
28 gennaio 2016
Linguistica da strapazzo (41): Afasia da personalità pubblica e metonimia onomastica
"Ciao Toponimo" - seguono ovazioni - è l'indirizzo di saluto che di norma l'artista pop rivolge oggi al suo pubblico. Esempi a bizzeffe. Quello qui esposto non viene da labbra italiane ma è, per brevità, il migliore che Apollonio abbia trovato in rete:
Integrare la documentazione non sarà del resto difficile per chi legge.
In "Ciao Milano" e nei comparabili, non si tratta, ovviamente, di prosopopea. Quella è la figura che si riconosce, per es., in "Arrivederci Roma" e in "Addio Lugano bella" e ne garantisce l'immediata perspicuità. Lì è il luogo, evocato come si deve con il suo nome proprio, a essere personificato e a farsi destinatario poetico (poetico in senso tecnico, cioè proprio per via della figura) di un atto enunciativo.
In "Ciao Milano" e nei comparabili, non si tratta, ovviamente, di prosopopea. Quella è la figura che si riconosce, per es., in "Arrivederci Roma" e in "Addio Lugano bella" e ne garantisce l'immediata perspicuità. Lì è il luogo, evocato come si deve con il suo nome proprio, a essere personificato e a farsi destinatario poetico (poetico in senso tecnico, cioè proprio per via della figura) di un atto enunciativo.
Quando lanciano il loro "Ciao Toponimo" ormai di rito, Emma o Alessandra Amoroso, Ligabue, Biagio Antonacci o Tiziano Ferro si rivolgono invece direttamente a esseri umani, di cui ignorano i nomi personali. In proposito, l'enunciatore è come fosse affetto da una afasia specifica e selettiva. Questa gli renderebbe impossibile la comunicazione calda e personalizzata che ogni personalità pubblica simula di intrattenere con i suoi sostenitori.
Nell'indirizzare un saluto rituale che è anche una captatio benevolentiae, soccorre allora l'artista una metonimia. Tutti coloro che assistono allo spettacolo in un luogo, prendono il nome del luogo, per contiguità spaziale: il rito della denominazione è compiuto, l'afasia superata, il nome proprio è proferito, nel suo valore magico. Seguono ovazioni, come si diceva.
Ciò che oggi accade negli eventi musicali, accadeva del resto nei politici, un tempo. Per gli appelli diretti al suo pubblico, chi teneva un comizio ricorreva alla stessa risorsa. Non è forse il solo tratto comunicativo che permette una comparazione tra i due generi di evento sociale, il perento e l'attuale.
Qualcuno ha detto che non c'è suono che giunga più dolce e accattivante alle orecchie di un essere umano di un nome che sente come proprio. Chi partecipa a eventi di massa bisogna naturalmente che si accontenti. Né si può escludere del resto che vi partecipi proprio per accontentarsi e per ascoltare come proprio un paradossale nome collettivo nel quale riconoscersi, perdendovisi.
24 gennaio 2016
Trucioli di critica linguistica (23): Ambiguità di "C'eravamo tanto amati"
Utile per mettere a fuoco l'ambiguità in questione è forse un esempio peregrino, nel contesto, ma piuttosto semplice e intuitivo, ci si augura.
Si ponga di assistere alla reciproca spulciatura di due scimmie. Si descriverà appropriatamente la scena dicendo Le scimmie si stanno spulciando. Si metta a questo punto che, dopo averlo fatto vicendevolmente, ciascuna delle due scimmie continui con la spulciatura di se stessa. Si descriverà la scena dicendo di nuovo Le scimmie si stanno spulciando.
Ecco: sotto condizioni sintattiche che qui non mette conto di enumerare pedantescamente, per non rendere il frustolo ancora più indigeribile, l'italiano ha forme che non distinguono tra diatesi reciproca e diatesi riflessiva. E se si vuole renderle diverse formalmente si deve dire più di ciò che capita di proferire di solito e per brevità, confidando in proposito nella chiarezza che viene dal contesto e da conoscenze pregresse.
Sulla falsariga dei primati e delle pulci (o della pulce del primato), di nuovo, un paio di esempi, forse oggi ancora più semplici e intuitivi. Il Matteo padano e il Matteo toscano si disprezzano: per renderne esplicita la reciprocità, si può aggiungere un vicendevolmente (o un reciprocamente, un l'un l'altro). Ma non si finisce così per essere ridondanti, in funzione del contesto? Sapendo un po' come i due Mattei oggi si presentano, a chi mai verrebbe in mente, ascoltando quell'espressione, che 'il Matteo padano disprezza se stesso e il Matteo toscano disprezza se stesso' e quindi un'interpretazione riflessiva?
In modo converso, aperte ragioni contestuali escludono si intenda come reciproca Il Matteo padano e il Matteo toscano si piacciono. Si sa benissimo infatti che ciascuno piace a se stesso e pochissimo o per nulla l'uno piace all'altro. D'altra parte, con simili esempi cervellotici, delle attitudini dei due personaggi evocati, ci si guarda bene dal fare una spicciola psicologia del profondo.
I valori implicati nell'ambiguità formale del titolo del film di Ettore Scola dovrebbero essere chiari, a questo punto.
C'eravamo tanto amati ha infatti un'interpretazione reciproca. Si tratta dell'interpretazione che sta più in superficie, della più evidente e corriva in funzione di un plot narrativo tanto noto da rendere superfluo che qui lo si riassuma. Di essa sola si sono del resto dovuti accontentare coloro ai quali titolo e film si sono presentati in lingue che, quanto al rapporto tra funzioni e forme, impongono in proposito il cilicio dell'univocità. E se ne sono accontentati, probabilmente, senza sapere che stavano perdendo qualcosa.
C'è poi infatti l'altra interpretazione, quella in virtù della quale l'espressione C'eravamo tanto amati dichiara, in chi la proferisce e associa al medesimo sentimento altri di cui si fa araldo, un amore riflessivo.
Che l'interpretazione riflessiva sia di norma oscurata dalla reciproca non deve ingannare né deve farla prendere per minore o accessoria. Al contrario e a ben vedere, la riflessiva pare avere una portata maggiore della sua concorrente, quando ci si propone di capire qual senso abbia l'opera di Scola.
La reciproca copre il plot, la vicenda narrata. Al di là del semplice plot, la riflessiva vale come descrizione rivelatrice dell'attitudine che ispira l'atto medesimo di narrarlo. Un atto che dichiara un sentimento riflessivo che si qualifica come narcisista, còlto pure che sia in un suo momento passato (l'imperfetto è il modo narrativo per eccellenza, d'altra parte).
In altre parole, lo specchio sarà pure invecchiato, ma belli e buoni come ci si sembrava, ci si sembra ancora. E, se si è stati buoni e belli tanto da innamorarsi riflessivamente, di amarsi è difficile si smetta. Nessuno ignora peraltro che i sentimenti riflessivi sono i più solidi, persistenti e affidabili. Chissà perché non è ancora venuto in mente di rivendicarne il valore in un opportuno quadro normativo. Se non ha giustamente genere, perché l'amore dovrebbe infatti avere un numero? Per giunta, un numero necessariamente plurale? L'amore ha anzitutto diatesi. Ma di ciò e dei curiosi risvolti etici e teoretici, (Apollonio lo promette) un'altra volta.
Narrando allora una storia di amori reciproci, C'eravamo tanto amati, con le persone della sua enunciazione, con chi se ne fa enunciatore e con chi se ne fa enunciatario, dice anche, se non soprattutto, di un amore riflessivo. E chi non ha amato quel film, amandosi anche per questo? Chi, tra i suoi estimatori, non vi si è riconosciuto con morbido e nostalgico sentimentalismo, certo, per le qualità fatte oggetto di narrazione, ma anche, se si vuole, per i difetti?
E oggi, con la triste notizia della morte del regista, il sentimentalismo ritorna. Unanime, stavolta, e nostalgico al quadrato, si potrebbe dire, perché nostalgico dei tempi in cui un film rivendicava nostalgicamente i tempi passati di un amore narcisista mai perento.
Con il suo titolo ambiguo e con i suoi intenti emblematici, peraltro perfettamente giunti ad effetto, il film di Ettore Scola è allora spia acutissima se non della psicologia profonda, certo dei modi con cui una parte di rilievo della nazione italiana si atteggiò sin dal principio della storia politica unitaria, continuò a fare in alcune cruciali circostanze storiche e dei modi con cui ancora oggi, stancamente, si atteggia: un sentimentalismo narcisista. Lo stesso meno sottilmente riflesso nel recente Noi credevamo il cui titolo e la cui fonte d'ispirazione condividono e non per caso, con C'eravamo tanto amati, persona grammaticale, la tremenda quarta, e tempo verbale, il fantasioso imperfetto. La parte in questione è quella che, della nazione, si pretende, se non è proprio, la culturalmente preminente e che ha tentato, a tratti, di farsene l'egemone, politicamente e socialmente.
Si tratta di un ceto forse per essenza narcisista. Così paiono dire (impossibile sapere quanto consapevolmente) l'ambiguità del titolo del film di Scola e, se ci si pensa un po', il film nella sua interezza, una volta si sia in possesso dell'appropriata chiave di lettura.
Concettualizzare l'esistenza di un tale amore narcisista, perduto a più riprese (vien fatto di dire con un filo di ironia) ma mai completamente abbandonato, dovrebbe indurre a riflettere chi prova a capire come sono andate e come vanno le faccende nazionali, anche attraverso le opere d'arte che la nazione esprime e in cui la nazione si riconosce.
Una consapevolezza del genere potrebbe d'altra parte sviluppare la capacità di uno sguardo finalmente critico (autocritico? Improbabile: di narcisismo si tratta), al di là del dolore che suscita il sapere morto chi ha dato voci e immagini artistiche a un morbido amore di tal fatta, creando appunto le ambiguità sentimentali di uno splendido specchio.
[A sera, in poltrona, tra le mani il Corriere. "Una battuta è l'ultimo regalo di Scola", taglio basso di prima pagina, la rubrica è Padiglione Italia, la firma è di Aldo Grasso: lo si può leggere qui.]
22 gennaio 2016
15 gennaio 2016
Scherza coi santi... (8): Sopra un "codesti" di Caproni traduttore di Baudelaire, chiosa a una chiosa del frustolo precedente
"Que cherchent-ils au Ciel, tous ces aveugles?" scrisse Baudelaire. E Giorgio Caproni, traducendo: "Che van cercando in Cielo | tutti codesti ciechi?"
Cosa ci sta a fare quel codesti? Allontana i ciechi dal "je" che, anche lui appunto, si trascina e che si dice inebetito più di loro. Li pone nell'area di pertinenza di un "tu" che, nel componimento, è la "cité" ed è chi legge, se si sale dal livello dell'enunciato a quello dell'enunciazione (dove "je" è naturalmente l'enunciatore).
Il testo è una procedura (un "processo", diceva un caro sodale di Apollonio). C'è da chiedersi se, in tale procedura, l'operazione sia felice, sia ben riuscita. Non solo in funzione di una corrispondenza al sistema da cui si sprigiona l'originale - corrispondenza certo sempre impossibile, sempre idealmente da perseguire, tuttavia -, ma anche in funzione del sistema (lo si vuole considerare in autonomia?) in cui si proietta la nuova creazione. "Tutti questi ciechi" sarebbe stato corrivo? "Tutti codesti ciechi" non sarà corrivo ma è forse troppo loquace e sfiora la belluria.
C'è poi in quel codesti un quid di spregio. Lo spregio è connesso con la presa di distanza di cui s'è detto. Una simile presa di distanza non c'è sotto la penna di Baudelaire, che coi ciechi è invece simpatetica.
Ecco dunque che questa traduzione funge da cartina di tornasole, per Apollonio. Contrastivamente, staglia con nettezza, ai suoi occhi di lettore di Caproni, un tratto idiosincratico del poeta livornese (e genovese. E romano?).
Ora che vede in chiaroscuro questa linea di spregio nella parola di Caproni (codesti, la parola che Caproni rivendica per se stesso, in questa traduzione), Apollonio capisce di averla sempre percepita nell'insieme della sua opera, senza essere mai prima riuscito a trasformare il percetto in concetto. E gli pare così di intuire come mai l'ammirazione, grandissima, non sia mai sfociata in una simpatia.
Apollonio ritiene infatti che lo spregio sia consentito alla vita ma per farsi arte, come per farsi ricerca, deve diventare sprezzatura.
14 gennaio 2016
Sommessi commenti sul Moderno (22): "Que cherchent-ils au Ciel, tous ces aveugles?"
Il succo di questo frustolo sta nell'immagine che, in apertura, l'illustra e che illustra un articolo giornalistico su recenti e futuri sviluppi nel settore economico della cosiddetta realtà virtuale (ossimoro esemplare: ma di ciò, eventualmente, un'altra volta).
Testa piegata all'indietro, come a guardare verso l'alto, bocca aperta: la postura della persona che occupa il primo piano di tale immagine è loquace.
È una postura umana che attraversa i tempi e, sotto determinate condizioni, è specifica della specie, ragionevolmente. Essa è per esempio descritta e valorizzata da un testo canonico ed esemplare del Moderno maturo, Les aveugles di Charles Baudelaire:
"Contemple-les, mon âme; ils sont vraiment affreux! | Pareils aux mannequins; vaguement ridicules; | Terribles, singuliers comme les somnambules; | Dardant on ne sait où leurs globes ténébreux. | Leurs yeux, d'où la divine étincelle est partie, | Comme s'ils regardaient au loin, restent levés | Au ciel; on ne les voit jamais vers les pavés | Pencher rêveusement leur tête appesantie. | Ils traversent ainsi le noir illimité, | Ce frère du silence éternel. Ô cité! | Pendant qu'autour de nous tu chantes, ris et beugles, | Éprise du plaisir jusqu'à l'atrocité, | Vois! Je me traîne aussi! Mais, plus qu'eux hébété, | Je dis: que cherchent-ils au Ciel, tous ces aveugles?"
In un momento precedente e aurorale del Moderno e sotto prospettiva differente, la medesima postura fu illustrata da un celebre dipinto di Pieter Brueghel il Vecchio:
Ed ecco, cambiando riferimento, tempo e arte, come la rappresentò, con il pretesto di un mito antico di autoaccecamento, Pier Paolo Pasolini, quando la putrefazione del Moderno era già cominciata da un po':
Insomma, si tratta della postura del cieco.
Per ancestrale desiderio, allora, l'accecamento della realtà virtuale come compimento del destino di un'era? L'impulso ad astenersi dalla visione dell'eccesso di bruttezze e di brutture già prodotte da quell'era? Come soluzione finale, la cecità richiesta da una realtà che è già virtuale e solo da perfezionare nei suoi aspetti più crudamente tecnologici?
Tutto ciò (ed è il lato comico della faccenda, che il Moderno non riesce mai ad allontanare da sé, soprattutto nella fase della sua putrefazione) con il pretesto di uno spasso e dell'accrescimento dell'esperienza perseguito paradossalmente attraverso la sua negazione.
Apollonio, forse già cieco anche lui, lascia però alle meditazioni dei suoi due pazienti e non ciechi lettori ogni conclusione (ma c'è, una conclusione?).
[I ciechi, nella traduzione di Giorgio Caproni: " Osservali, anima mia; son veramente orrendi! simili ai | manichini; vagamente ridicoli; terribili, strani come i | sonnambuli; i loro globi tenebrosi non si sa dove dardeggino. | Gli occhi, fuggita via la scintilla divina, come se | guardassero lontano, restano levati al cielo; mai vedi le loro | fronti appesantite chinarsi, pensose, al suolo. | Attraversano così il buio senza fine, fratello del silenzio | eterno. O città! Mentre a noi intorno canti, ridi e berci, | avida di piacere sino alla ferocia, guarda! anch'io mi | trascino! Ma, inebetito più di loro, dico: Che van cercando, | in Cielo, tutti codesti ciechi?"]
13 gennaio 2016
Lingua nostra (10): "Cruscaio", "cruscante", "cruscata"...
Cruscaio, cruscante, cruscata, cruscheggiante e cruscheggiare, cruscherìa e cruschesco, cruschevole e cruschevolmente...
Parole fuori dell'uso da qualche tempo ma italianissime e vive sotto le penne di Foscolo e Leopardi, di Baretti e Berchet, di Ojetti e D'Annunzio, di Settembrini e Tommaseo, tra gli altri. Gente che s'esprimeva in tempi forse più vivaci dei presenti. Tempi di "pane al pane e vino al vino". Quindi, di "Crusca alla Crusca".
Il merito dell'esistenza della bella famiglia lessicale va naturalmente all'Accademia della Crusca. Con le sue attitudini morali, con le sue pratiche espressive, con le sue scelte culturali (le storiche, s'intende; le presenti sono altra cosa: c'è bisogno di dirlo?), l'Accademia della Crusca ha infatti fecondato lo spirito dell'italiano, che ha originalmente partorito tali curiose e gustose espressioni di uno spregio.
Parole fuori dell'uso da qualche tempo ma italianissime e vive sotto le penne di Foscolo e Leopardi, di Baretti e Berchet, di Ojetti e D'Annunzio, di Settembrini e Tommaseo, tra gli altri. Gente che s'esprimeva in tempi forse più vivaci dei presenti. Tempi di "pane al pane e vino al vino". Quindi, di "Crusca alla Crusca".
Il merito dell'esistenza della bella famiglia lessicale va naturalmente all'Accademia della Crusca. Con le sue attitudini morali, con le sue pratiche espressive, con le sue scelte culturali (le storiche, s'intende; le presenti sono altra cosa: c'è bisogno di dirlo?), l'Accademia della Crusca ha infatti fecondato lo spirito dell'italiano, che ha originalmente partorito tali curiose e gustose espressioni di uno spregio.
11 gennaio 2016
Cronache dal demo di Colono (38): Checca Ciara
Difeso dalla pigrizia e dall'isolamento (le belle condizioni della Citera che lo porta sempre con sé), Apollonio non è ancora andato a vedere il recente film di Luca Medici. Se mai lo farà (la pellicola potrebbe frattanto essere scomparsa dalle sale), lo farà con la certezza che, comico che sia il film, difficilmente potrà esserlo più dello spettacolo offerto da chi lo spregia e si presenta in tal modo come personaggio di una nuova commedia dell'arte: insomma, l'antagonista ideale di Checco Zalone.
Senza pregiudizio quanto al genere di chi si avvicenda nell'interpretazione del ruolo (del resto, può ben farlo en travesti), Apollonio ne suggerisce il nome: Checca Ciara.
Senza pregiudizio quanto al genere di chi si avvicenda nell'interpretazione del ruolo (del resto, può ben farlo en travesti), Apollonio ne suggerisce il nome: Checca Ciara.
8 gennaio 2016
Vocabol'aria (16): "Intellettualini"
Il Meridiano consacrato ad Alberto Arbasino è corredato da una Cronologia. A tale Cronologia, l'autore ha apposto una premessa e l'ha chiusa con questa sorta di epochè: "(Più recentemente, masse di innumerevoli intellettualini in coppiette e famigliuole e "ruoli" sempre in crisi e in serie intimistica, fra divani-letto e angoli-cottura e posti-motorino e passeggini per pupi o paparini standard e uffici intercambiabili con capi e problemi e dialoghi comunque sostituibili, mai certamente imperdibili.)"
Nel passo, il "più recentemente" è naturalmente l'oggi o l'appena ieri che oggi si va confermando e, più che sospeso, il giudizio sull'oggi vi è camuffato ma trasparente. Esso è affidato a forme alterate diminutive (mere o simulate che siano): coppiette, famigliuole, motorino, passeggini, paparini.
Tutte forme dell'uso comune e ormai quasi autonome come parole, a fare da corte alla sola, intellettualini, in cui il diminutivo, come esplicita scelta d'autore, porta tutto il peso del suo valore e fa da culmine di un nesso privo di determinazione e ricco di assonanze che ne amplificano il senso: masse di innumerevoli intellettualini.
Nel suo valore che fu corrente nel secolo breve e che ebbe i suoi fasti a cavaliere dell'ultima carneficina europea, la parola intellettuale venne alla luce non più di cento venti anni or sono. Essa si è trascinata fino ad oggi per l'inerzia che, come si sa, caratterizza le parole, portando a lungo con sé le connotazioni terribili di stagioni meccaniche ed implacabili ma anche le dolci di una società che, come tutte le privilegiate, fece il sogno d'essere immortale.
La parole continuano a esistere anche quando è scomparso ciò che designano: passano a designare altro, che della continuità del fiato eventualmente si bea (o si danna: di recente, Apollonio ha in proposito segnalato il caso di università).
La parole continuano a esistere anche quando è scomparso ciò che designano: passano a designare altro, che della continuità del fiato eventualmente si bea (o si danna: di recente, Apollonio ha in proposito segnalato il caso di università).
La sensibilità linguistica di Arbasino annuncia che bisognerebbe prendere atto di tale mutamento. La storia della parola intellettuale è a una svolta. Si potrà pure continuare ad adoperarla ma varrà in ogni caso (e fino alla sua eventuale estinzione) solo per il suo diminutivo. Per onestà e per segnalare ai posteri (ammesso lo intendano) che del mutamento qualcuno fu sensibile e non tutti si fu accecati dalle apparenze, sulla scorta di Alberto Arbasino e regolarmente nell'uso sarebbe quindi il caso di cominciare a sostituire intellettuale con il suo diminutivo.
4 gennaio 2016
Parabole (4): Dalle "magnifiche sorti e progressive" al cambiamento climatico
Oggi si reputa capace di peggiorare il mondo, e sembra il contraccolpo di una disillusione, la stessa civiltà che, or non è molto, si credeva capace di migliorarlo. Nel comico rovesciamento di prospettiva, viene chiaro alla luce, per chi sa vedere, il costante carattere morale di tale civiltà, uscito evidentemente indenne dalla disillusione: la tronfia attitudine a presumere troppo di se stessa.
Iscriviti a:
Post (Atom)